
Il suo “arrivo” negli USA è stato difficile e tardivo. Inizialmente è stato rifiutato dall’establishment. Poi, nel 1985, dopo la pubblicazione del Sistema Periodico in inglese, è stato accolto con entusiasmo, grazie anche al sostegno di Saul Bellow. Proprio nello stesso periodo Levi è stato attaccato in maniera brutale da Commentary, per non essere “sufficientemente” ebreo e per le sue dichiarazioni sull’invasione israeliana del Libano [del 1982, n.d.a.]. Questo ha riguardato un’audience intellettuale molto piccola, ma l’influenza di quello scontro si è protratta nel tempo e per certi versi ne vedo ancora una traccia oggi nei tentativi di neutralizzare il suo impatto critico e politico. Nel mondo della “memoria dell’Olocausto” (uso una parola che Levi non usava, ma che è la parola ufficiale in America) Levi era visto con sospetto perché proponeva una riflessione umana e sociale che non trovava facilmente un posto accanto alla predominante epica religiosa di Elie Wiesel.
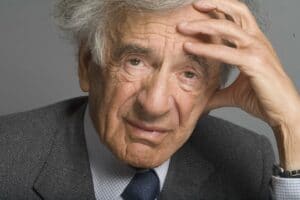
E poi il senso comune era permeato dall’idea che il Fascismo fosse stato una dittatura benevola e la persecuzione degli ebrei resa praticamente nulla dalla bontà d’animo degli italiani. L’apprezzamento del grande pubblico è arrivato prevalentemente in anni recenti culminando con la pubblicazione delle Opere Complete e parallelamente all’insorgere di un nuovo dibattito sull’uso strumentale della storia e sui limiti di una memoria acritica e esclusivista. La sua teorizzazione della “zona grigia” si è rivelata particolarmente feconda in molti campi di studio. Da qualche anno è in corso una certa glorificazione e inevitabilmente banalizzazione del suo lavoro. Le giornate su Primo Levi all’ONU, alla Library of Congress e più recentemente alla New York Public Library sono state pensate per problematizzare questa tendenza.
Ci può indicare, brevemente, su quali linee ha impostato l’attività del Centro?

Il nostro lavoro riguarda la storia degli ebrei italiani in molti suoi aspetti, incluso quello metodologico e storiografico e la scrittura di Primo Levi che è tema di studio ma anche una specie di bussola intellettuale. Il Centro ha una struttura orizzontale che include oltre allo staff e al board moltissimi collaboratori che portano e attingono idee e progetti. È in sostanza un’officina aperta. Ognuno dei direttori viene da un’esperienza diversa, istituzionale o non. Si sono aggiunti negli anni Jeff Keil matematico e banchiere molto appassionato dell’Italia che oggi divide la presidenza con Andrew Viterbi, e poi Sarah Wolf e la studiosa di poesia medievale arabo-ebraica Isabelle Levy entrambe con un doppio legame intellettuale e familiare al resto del gruppo.
New York è la più grande città ebraica fuori da Israele. Che significa fare cultura nella “Big Apple”? Il PLC dialoga con il mondo ebraico newyorchese?

New York è una città di tante lingue, religioni e culture. Siamo sempre stati in dialogo con i variegati e profondamente divisi mondi ebraici newyorkesi così come lo siamo con il resto della città. Il Centro esiste in relazione a questa realtà fluida e complessa. Grazie al lavoro di gruppo di cui ho detto all’inizio, il CPL è diventato oggi un’istituzione conosciuta sia per la sua attività di ponte tra archivi, università, e progetti di ricerca, sia per la sua presenza pubblica diffusa a fianco di istituzioni diversissime, che includono università, CUNY, NYU, Columbia e The New School, la Hebrew University, e i centri della cultura, New York Public Library, Asia Society, il MoMA, l’Istituto di Cultura, il Museum of Jewish Heritage, Jewish Museum, Carnegie Hall, l’ONU, la Library of Congress, … e poi i nostri amatissimi “pop-ups” luoghi cittadini sconosciuti nei quali montiamo istallazioni che invitano alla discussione sulla storia.
E per quanto riguarda l’Italia? Ci sono legami tra il PLC e il nostro paese?
Lavoriamo con l’Italia costantemente, principalmente con le università, gli archivi, i musei – a cominciare dal Museo Ebraico di Roma, con cui abbiamo realizzato bellissimi progetti –, con gli enti governativi e la diplomazia italiana, con centri di studio. Il CDEC è stato il nostro primo partner di ricerca ormai due decenni fa; naturalmente c’è il Centro Internazionale di Studi Primo Levi a Torino, il Centro Leo Levi di Firenze, il Centro dell’Università di Genova, la Biblioteca Renato Maestro di Venezia, con cui abbiamo realizzato un’interessante mostra virtuale alla Library of Congress.

In generale, il mondo ebraico americano ha idea dell’esistenza di un ebraismo italiano? E se sì, come siamo visti oltreoceano noi ebrei italiani?
È difficile generalizzare. Ci sono persone con molte conoscenze che hanno uno sguardo interessante e creativo sull’ebraismo italiano, persone che hanno interesse e conoscenza ma hanno mantenuto una posizione di condiscendenza, persone con la testa piena di stereotipi e persone che non ne sanno alcunché. La stessa cosa direi dell’inverso. La visione dell’America che emerge dai giornali (ebraici e non) in Italia ha la stessa macedonia di attitudini.
E dal suo punto di vista? che idea si è fatta (se pure ne ha una) dell’ebraismo italiano?
Non riuscirei a ridurre a un’idea un mondo che per molti aspetti conosco intimamente e per altri ho avuto modo di guardare da lontano per molti anni. Un mondo così piccolo che riesce a mantenere tradizioni, coscienza storica, compagine comunitaria (conflitti compresi), attività umanitaria, adattandosi ai tempi e rivisitando il rapporto con la popolazione maggioritaria è una specie di miracolo. Gli anni di attività del Centro Primo Levi sono un affresco dei tanti modi in cui abbiamo pensato all’ebraismo italiano. In questo arco di tempo l’ebraismo italiano è cambiato molto e noi anche.
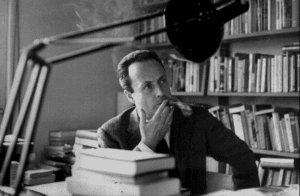
Un’ultima domanda. Progettare cultura significa anche immaginare il domani. Gli Usa sono quasi a metà dell’amministrazione Biden, il Covid non è ancora debellato e da 6 mesi sono coinvolti in una guerra di cui non si intravvede la fine. Come vivono gli Stati Uniti questo momento di incertezza e turbolenza, e, più in generale, qual è il compito e la responsabilità di chi fa cultura di fronte al futuro?
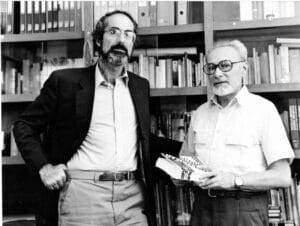
Alla grande domanda può forse rispondere la Sibilla Cumana. Nel piccolo di chi fa cultura si potrebbe cominciare a mettere in discussione l’incompatibilità tra quello che proponiamo di discutere e studiare e strutture istituzionali ormai piegate alle logiche quantitative e promozionali che lentamente ne logorano la rilevanza. Solo per fare un esempio, idee come quelle di “leadership”, “identità”, “eccellenza” o “best practice” (la lista è lunga), sono sostanzialmente vuote come la loro radice suprematista e i loro effetti dal punto di vista intellettuale ed etico sono sotto gli occhi di tutti. Questo non impedisce che vengano ammirate nel mondo della cultura e dell’educazione come se fossero soluzioni ai problemi che invece contribuiscono a creare. Penso che se c’è una minima possibilità che la cultura abbia un effetto, è proprio – come ha scritto Primo Levi – negando il nostro consenso.
Per la serie “Donne del mondo ebraico”, leggi anche:
Pacifica Di Castro e Sara Copio Sullam




Una risposta
L’ultima frase dell’intervista è veramente importante: idee come quelle di “leadership”, “identità”, “eccellenza” o “best practice” (la lista è lunga), sono sostanzialmente vuote come la loro radice suprematista e i loro effetti dal punto di vista intellettuale ed etico sono sotto gli occhi di tutti.
Grazie Natalia!