
Circa 20 anni fa il prof. Ugo Volli, mio allievo, si presentò da me con la sbobinatura di circa 30 mie lezioni, esortandomi a ricavarne il materiale per una o più pubblicazioni. Mi misi a lavorarci sopra, ma ne ricavai solo una quindicina di pagine. Poi capitò che feci 12 lezioni al Teatro Del Verme, a Milano, grazie all’idea di Andrée Ruth Shammah. Fu un successo inaspettato, con migliaia di persone in sala e il foyer stracolmo. Tra i presenti, anche Stefano Mauri (direttore editoriale Garzanti, n.d.r.), che mi spronò a scrivere, e così è uscito il primo libro. Vede, direi in generale che per me l’aggettivo che descrive la scrittura è “santità”. Per me la scrittura è una cosa statica che mi blocca enormemente. Devo anche dirle che non ho una grande stima dei miei libri, rimango stupito del vedere che hanno successo. È un po’ come le mie conferenze: sono sinceramente molto sorpreso. D’altra parte, mio padre, col suo sorriso, mi ha insegnato: non farti piccolo, perché non sei così grande.
Lei è nato in Francia, mentre la sua famiglia è di origine polacca; da molti anni però vive in Italia. Che impressione ha degli ebrei italiani?
Sono nato a Parigi nel 1947 dove i miei erano arrivati con tutto ciò che avevano: nulla, a parte il “pigiama a righe” di mio padre e di mia madre. Quando sono arrivato in Italia sono stato accolto molto bene, meglio che in Francia. Sull’ebraismo italiano però non saprei dire molto. A Milano gli ebrei italiani sono pochi, perché lì vive soprattutto un raggruppamento di ebrei esiliati. Anche il rabbino capo (rav Alfonso Arbib, n.d.r.), cui diedi qualche consiglio all’inizio, è in realtà non italiano, ma libico. Quando venni a Milano cominciai a frequentare il tempio italiano, facevo lezione a Minchà di Shabbat, poi il rapporto si è interrotto. Oggi il mio pubblico è formato soprattutto da non ebrei. Il mondo non ebraico è in generale attento alle mie lezioni, al punto che, a settembre, sono stato invitato a titolo personale a partecipare al Forum del dialogo interreligioso, organizzato nell’ambito del G20, che si terrà a Bologna, e dove terrò una lezione sull’Havdalà. Quello di cui a volte mi rammarico, senza capirne la ragione, è invece che con le istituzioni ebraiche non ci sia mai stato un ottimo rapporto. Tuttavia credo anche che da ciò occorra riuscire a trarne un insegnamento. A volte è dalle contrapposizioni, dalle piccole polemiche, che nasce per me lo stimolo che mi costringe ad approfondirmi. Quando sei sul palco, e tutti ti apprezzano, si ha la sensazione opposta: pensi di essere qualcuno. Devo dire che in questo gli ebrei mi richiamano alla realtà.

Che cos’è per l’ebraismo la libertà? Ritiene che oggi, al tempo della narrazione dettata dai social, sia più facile o più difficile essere liberi?
Questa è una domanda fondamentale. Cos’è la libertà? Tutti dicono “la mia libertà finisce dove inizia quella altrui”, e questo è evidente, però non basta. Io penso che a Pesach vi è il vero insegnamento della libertà. Se lei nota, a Pesach viene poco enfatizzato la sofferenza della schiavitù, di cui certo si parla, ma non è questo che conta. Di cosa si parliamo nel Seder? Se legge la Haggadah con occhi nuovi, vedrà che l’accento è messo su due punti: abbiamo un’origine idolatrica, perché nasciamo da Terach, e non saremmo mai usciti dall’Egitto da soli. Dunque da ciò impariamo che non ci può essere libertà con una narrazione idealizzata delle proprie origini, e che siamo stati liberati a seguito di una Shoah. Dall’Egitto è uscito solo 1/5 degli ebrei, i 4/5 sono morti; è lo stesso rapporto degli ebrei morti nella Shoah del Novecento. Quindi, usciamo dall’Egitto perché siamo stati letteralmente spinti fuori. E allora dove sta la libertà? Sta nel non raccontarsi storie immaginarie su di sé. Prenda lo Stato d’Israele. Fino a 15 anni fa è stata narrata la sua origine in modo quasi mitico, come una leggenda, come una fiaba per bambini; poi sono arrivati i nuovi storici, che hanno distrutto malamente questa narrazione, proponendone un’altra, anch’essa unilaterale. Per questo oggi si fa fatica a trovare le soluzioni economiche, politiche e sociali adeguate in Israele: perché ci siamo raccontati una nascita fantasiosa. Dobbiamo invece riconoscere la realtà del nostro percorso; in caso contrario si apparirà come figlio della storia che si è raccontato agli altri, e avremo perso la libertà. La conoscenza della propria storia aiuta a possedere una mente libera, un cuore e dei sentimenti liberi.
E noi ebrei, a suo avviso, corriamo questo rischio oggi?

Mi permetta un riferimento alla Torah. A volte è scritto “Ha-yom”, “oggi”, per introdurre un precetto. Per esempio è scritto: oggi non si mangia il nervo sciatico. La motivazione che la Torah ha dato a suo tempo per la mitzvà è forte: Yaakov subisce un colpo al nervo sciatico perché deve incontrare suo fratello da claudicante, perché è l’unico modo per salvarsi. Che valore ha però dire “Ha-yom” ancora oggi? Significa che anche noi, “oggi”, dobbiamo immaginare una motivazione adeguata per non consumare il nervo sciatico. Allora oggi dobbiamo capire che dobbiamo considerarci tutti claudicanti; questa è la nostra storia. Quello che invece caratterizza gli ebrei dell’esilio è l’ansia di mostrarsi uomini di successo: gli ebrei sono ricchi, intelligenti, vincitori di Nobel. Questo è l’ebraismo della diaspora, l’unico modo di sopravvivere in diaspora. In questo modo abbiamo portato la mentalità dell’esilio in Israele, che oggi sente la necessità di definirsi nazione start up, high-tech, ecc. Ma questo non c’entra niente con l’ebraismo, perché Israele è anche un paese dove c’è molta povertà. Allora quella rappresentazione ci aiuta? La Torah dice anche (Dt, 16, 19-20): “non accetterai doni”, e “la giustizia, la giustizia perseguirai”. A che fine? “Affinché tu viva e possa ereditate la terra che D.o ti sta per dare”. Questa è la libertà. Israele certo è nato per merito dei primi pionieri, moltissimi provenienti dalla Russia zarista, ma in realtà la libertà è riconoscere questo nostro compito.
Un’altra fragilità del nostro tempo è quella politica, come mostra la realtà tragica che abbiamo da giorni sotto gli occhi. Kabul che capitola, e una nuova stagione di violenza alle porte. Da ebreo occidentale, quelle scene cosa le suggeriscono?

È per me difficile dare dei giudizi su una realtà così complessa. In generale, noi occidentali abbiamo, secondo me, passato il tempo a tracciare frontiere e confini, per comodità propria: questo è stato il colonialismo. La resa di Kabul dimostra il nostro fallimento. L’Afghanistan è il più grande produttore di oppio, ma siamo noi che abbiamo creato questo paese, dove ci sono da 7 a 9 tribù completamente diverse tra loro, e non abbiamo mai lasciato che l’unificazione arrivasse da dentro. Non avevamo alcuna fiducia nei popoli che incontravamo, di nuovo perché abbiamo dimenticato le nostre origini. Eppure, ancora una volta la Torah insegna. Per quanto riguarda Israele, infatti, dobbiamo ricordare che nasciamo da 12 tribù, che hanno 12 vocazioni diverse, che andavano pochissimo d’accordo tra loro, fino alla scissione dopo Salomone, sancita a Shechem (dove Giuseppe era stato venduto dai fratelli). La Torah ci insegna la difficoltà e l’impegno nel ricercare una convivenza tra diversità. Quando noi diciamo “A. Elohneu, A. echad”, noi non diciamo tanto che D. è uno, ma che combattiamo la monolatria. Quando diciamo “echad” intendiamo dire che la pluralità delle manifestazioni divine coesistono, sono unificate. Sul piano politico dobbiamo essere capaci di convivere con identità ricchissime, nel rispetto che non abbiamo mai avuto nei territori dove siamo andati colonizzando e massacrando. Il cristianesimo racconta questa storia, perché è colonizzatore, mentre l’ebraismo non lo è.
A proposito di Europa: teme la xenofobia europea, e le punte di antisemitismo raggiunte in paesi come Ungheria e Polonia?

È un timore concreto. Oggi ho paura dell’antisemitismo, che è presente anche in Francia, anche in Italia. Come si può combatterlo? È difficile da dire. Certo parlare, spiegare. Ma è molto difficile. In Francia, per esempio, alla terza generazione di immigrati arabi oggi c’è un antisemitismo islamico, molto potente, che si aggiunge all’antisemitismo di una Francia profonda, che viene nascosto. Tra l’islamismo e il lepenismo, sono molto pessimista. In Italia vedo i dati dell’osservatorio dell’antisemitismo, l’esistenza dell’antisionismo antisemita. Sembrerebbe però che il paese abbia la fortuna di essere la patria del “cattocomunismo”, più al riparo dal moderno antisemitismo. Tra i miei ascoltatori e lettori ci sono ormai i figli dei cattocomunisti degli anni Settanta, e questo in qualche modo mi rassicura, anche se ritengo che ci sia una destra molto pericolosa.
L’antisemitismo richiama inevitabilmente la Shoah. Noi ebrei veniamo considerati tra i maggiori cultori della memoria, al punto che “Giorno della memoria” è chiamato quello in cui si ricorda la Shoah. Qual è il giusto equilibrio tra memoria del passato e sguardo verso il futuro, che da sempre fa dell’ebreo una figura dinamica che anticipa i tempi e li rinnova?
Ho sempre trovato assurdo il culto della memoria celebrativa, pur essendo figlio di deportati. Io combatto la memoria celebrativa perché è totalmente contraria all’ebraismo. Vede, la memoria che conta è quella che mi insegna come si esce dalla Shoah, o come si esce dal fascismo. È inutile celebrare passato, il lavoro da fare è tutt’altro. Quando mi chiedono cos’è la Torah, dico che la Torah è memoria, ma la memoria non è la storia. E infatti nella Torah la descrizione della schiavitù in Egitto è racchiusa in poche righe, perché non è quello che conta; quel che conta è come uscire dalla servitù. Guardi la prima della 10 Parole: “Io sono il tuo D.o che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa di schiavitù. Quel “bet” (casa, n.d.r.) è il cuore del precetto: dobbiamo superare la “nostra” schiavitù, che come dice Hegel è l’accettazione di sopravvivere, invece di vivere. Se non comprendiamo la seconda parte del precetto, possiamo liberarci della forma esteriore di schiavitù, ma non di quella interiore. Bisognerebbe parlare con i giovani e spiegare che dal rischio di un nuovo fascismo non si esce con la memoria celebrativa, ma spiegando cosa c’è di letale oggi nell’adorazione fascista, che male ne deriva.
 Ci stiamo preparando ad entrare nel nuovo anno. Che augurio si fa per l’anno che arriva?
Ci stiamo preparando ad entrare nel nuovo anno. Che augurio si fa per l’anno che arriva?
Vorrei che i cuori si aprano un po’ di più e si presti attenzione a chi ha bisogno. Di buone parole ne sento sempre tantissime, poi quando si passa alla pratica c’è poca solidarietà. Per l’anno nuovo mi auguro che gli uomini di buona volontà diventino anche uomini di buone azioni.
Tornerà a fare lezioni di Torah a Roma?
Se mi invitano, verrò volentieri.


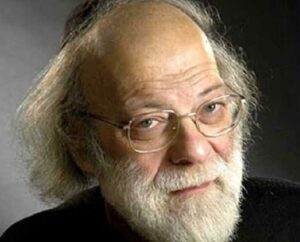

Una risposta
Non oso, non oso fare commenti perché non so, ma che bello leggervi stimola la mia curiosità, mi porta come una foglia a volare…. Dopo mi poseró insieme ad altre foglie e spero di essere comunque utile a un piccolo esserino che cerca un riparo. Ciao Baharier