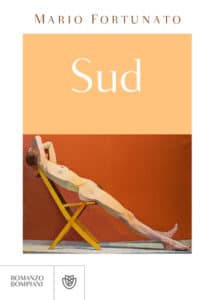Memoria, famiglia, radici: “Sud”, di Mario Fortunato
Una famiglia calabrese attraversa il Novecento tra ricordi, lutti, amori e la nostalgia per un passato ignorato, eppure presente: quello delle proprie radici ebraiche

Fin dal prologo ci sentiamo immersi in un’atmosfera da Antologia di Spoon River, con echi delle bellissime canzoni di De André ispirate a quell’opera. Ma questo romanzo non è solo un’elegia, un omaggio, un canto.
È un immergersi in un oceano profondo, in cui l’autore/personaggio principale ritrova il proprio sé riflesso in un’origine che per molto tempo ha tenuta nascosta a se stesso, e i cui personaggi torneranno nei sogni.
I personaggi sognati dal protagonista, Valentino, che appare solo a metà del romanzo, vengono descritti con precisione, nostalgia e amore, ma anche con molta ironia. Vi è visione e un ritmo che ricordano “Cent’anni di solitudine”: le descrizioni, talvolta iperrealiste diventano improvvisamente magiche o surreali.
La storia si svolge in un periodo che va dagli anni Venti del Novecento agli anni Settanta: il racconto delle vicende di una famiglia calabrese della borghesia medio-alta, colta e con ruoli istituzionali, si dipana sullo sfondo delle terribili catastrofi del Novecento. Si racconta un sud borghese, anche politicamente molto impegnato, intellettuale, la storia della famiglia, allargata, dell’autore. Una storia che improvvisamente, a un certo punto, chiede e pretende di essere raccontata.

I sogni chiedono di essere trasformati in memoria. Nominare, anche se non con i propri nomi, i membri di questa famiglia sembra laicamente riprendere l’antica tradizione ebraica di nominare, al termine di Shachrit e Arvit, i morti almeno una volta l’anno, ricordarli e saperli nel Gan Eden. Ma non è, talvolta, la letteratura, un eterno nominare i morti, un eterno augurare loro ciò che forse non hanno avuto in terra, la redenzione?
L’origine dunque ritorna, esplosiva, nel racconto, nell’epilogo, di un’esperienza involontaria e rivelativa, a sua volta tornata nell’abisso e poi riemersa, infine, come segnale di un necessario confronto con l’origine stessa. Non tanto l’origine ebraica di una parte della famiglia, innestata nella provincia calabrese, ma il fatto stesso di avere, o non avere più, una famiglia. Alla morte dell’ultima zia paterna “scoprì di essere rimasto solo davanti alla morte”.

Se non c’è più nessuno, se ogni familiare è morto, resta il racconto, il ricordo, la memoria, che diventa un dovere. E l’origine ebraica della famiglia materna si espande e insieme si concretizza in un comando, che Primo Levi ha espresso in parole dagli echi biblici: “Meditate che questo è stato:/ vi comando queste parole.”
Ma non è la Shoah, che pure balena nel finale, a provocare il momento del silenzio e della svolta (l’inversione che solo per assonanza qualcuno chiama Teshuvà), ma il toccare l’origine, il sé, la madre, il padre, ciò da cui veniamo e a cui, infine, torniamo. Ciò che, in fondo, siamo. Un dolce, una carezza, un saluto mancato, un canto.
Come dice Karl Kraus, “L’origine è la meta”. E nell’epilogo di questo bellissimo libro risplende, come un dono, l’abbraccio di mia madre.
“Sud”, di Mario Fortunato. Bompiani, 2020. Leggi un estratto