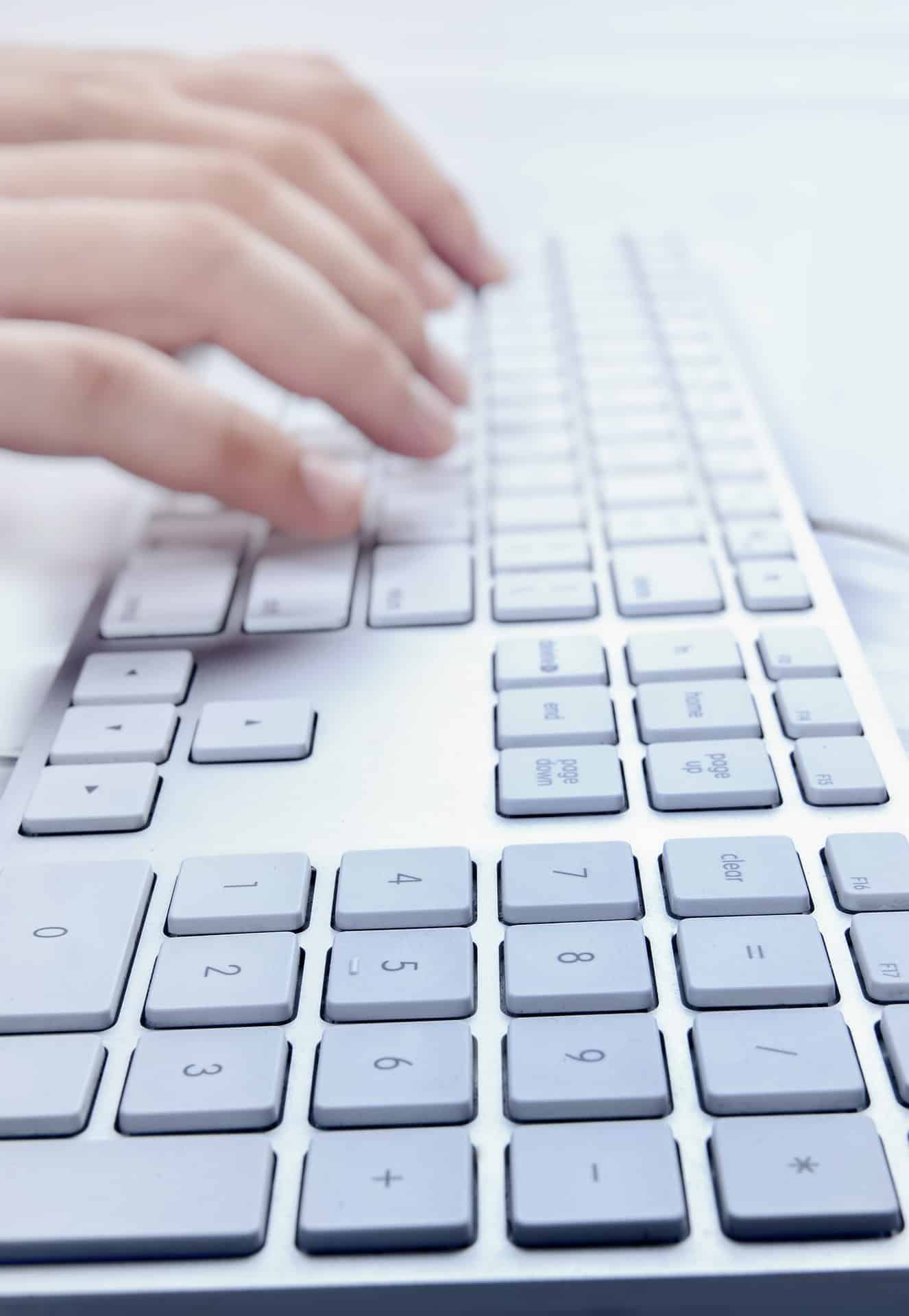Mark Rothko: il colore comunica in silenzio
E’ in corso a Parigi la più grande retrospettiva dell’autore lettone-americano (1903-1970) famoso per le sue tele in cui colori e dimensioni richiedono ascolto e interpretazione, nella migliore tradizione ebraica
“…vai e studia. Tutto il resto è commento”.

Termina così il celebre aneddoto talmudico con cui rav Hillel risponde con pazienza a quell’anonimo straniero che, forse in modo più provocatorio che ingenuo, gli chiede di conoscere con poche parole in cosa consista l’essenza del pensiero ebraico.
È a rav Hillel, e al suo sconosciuto interlocutore, che viene da pensare appena usciti dalla retrospettiva, visitabile alla Louis Vuitton Foundation di Parigi, su Mark Rothko, nato Marcus Rothkowiz in Lettonia (a quel tempo una delle Repubbliche russe) nel 1903, ed emigrato ancora ragazzo a Portland, Oregon.

La mostra, visitabile fino al 2 aprile, si conferma davvero unica, per il numero delle tele esposte, 115, molte delle quali non visitabili altrove – perché detenute da collezionisti privati – che consentono di apprezzare l’intera parabola artistica di Rothko, dalle prime opere, ancora figurative, degli anni Trenta, fino alla serie, incompleta, “Black and Grey”, interrotta nel 1970, anno del suicidio.
I visitatori, in maggior parte, sono curiosi di osservare le tele che hanno reso celebre Rotkho già in vita: i suoi pannelli cromatici, quasi tutti rettangolari, orientati per lo più orizzontalmente, dalle grandi misure (circa due metri d’altezza per uno di lunghezza, tranne il maggiore, che sfiora i tre metri per due), al cui interno rettangoli di colore si pongono davanti all’osservatore.
L’esperienza, per chi è del tutto incompetente in materia d’arte, è un viaggio in un universo simbolico sconosciuto. Come gli ominidi di Kubrick davanti al monolite, anche qui, passando di sala in sala, si avverte che le tele, parallelepipedi silenziosi, trasmettono un codice di significato di cui nessuno probabilmente custodisce il cifrario.

Mentre le variazioni cromatiche si susseguono – dapprima prevalgono i gialli, i verdi e gli aranci, poi gli ocra coi viola, poi ancora i blu, i marroni, i rossi, quindi ancora i viola e i neri, fino ai grigi e ai neri che dialogano con le donne altissime di Giacometti – appare sempre più vano cercare una risposta interpretativa unica e generale che faccia comprendere il significato dei quadri.
Ad aiutare, quel poco che si può, durante il percorso, alcune tracce audio, e poche frasi anonime, quindi da attribuire a Rotkho stesso, sistemate talvolta sui pannelli all’ingresso delle sale.

Ma sono soprattutto le frasi di Rotkho ad aiutare il viandante. Quella che, ad esempio, candidamente rivela che nemmeno l’autore ha una sua interpretazione autentica delle tele, le quali si offrono a chi le guarda chiedendo in cambio una esperienza immersiva, in cui la fiducia richiesta all’opera permette di ricevere in cambio nuove percezioni; e quella che riconosce in ogni tela un invito ad accogliere una dimensione spirituale.
E così, giunti quasi alla fine, dopo aver attraversato la sala che riproduce la Tate Gallery di Londra (l’unica allestita direttamente secondo le indicazioni dell’autore), dalle tinte cupe e meditative, o la Rothko room della Philips Collection, vivace e luminosa, ed essere approdati alla sala n. 9, la più grande e per questo più impressionante, ecco che una possibile lettura si offre agli occhi e, appunto, all’animo.

La seconda percezione è che, per intuire un possibile significato delle tele, occorre abbandonare ogni atteggiamento emotivo statico, ma dare, in un certo senso, il proprio contributo: le opere di Rothko non chiedono nulla, ma se siamo noi a domandare loro qualcosa, allora la risposta è: interpretami. Come ha scritto l’autore: «Un quadro vive in compagnia, dilatandosi e ravvivandosi nello sguardo di un visitatore sensibile».
La terza percezione, infine, è che una metafisica dei colori e una partecipazione ermeneutica dell’osservatore possono essere esperienze scaturite forse solo dall’opera e dal talento di un uomo che da ragazzo aveva studiato Talmud in qualche yeshivà lettone, e che in famiglia aveva ascoltato chissà quante volte le parole e i commenti alla Torà pronunciati dal nonno rabbino.
Solo l’erede di una famiglia di ebrei lettoni cresciuto studiando Talmud poteva infatti concepire opere fluttuanti di colore, ma prive di qualsiasi immagine e figura, senza neanche un nome – le opere della maturità sono solo una serie di numeri, una sequenza suddivisa per anno – ciascuna delle quali chiede a chi guarda di interpretarle.
La pittura di Rothko, insomma, sembra conservare una irriducibile identità ebraica, che né il successo sensazionale della sua maestria nello stendere i colori né la frenesia della vita americana hanno potuto intaccare (celebre, ad esempio, il suo rifiuto di consegnare le tele commissionate da un celebre ristorante di New York, perché non avrebbero mai potuto dialogare con ambienti destinati a fare tutt’altro che meditare).

Tutto il resto è commento.