Esther tra ambiguità, tragedia ed euforia
Soprattutto in tempi come quelli attuali, la Meghillà e il suo finale ci interrogano e ci invitano a evitare facili interpretazioni

Presentando un recente libro dedicato alle interpretazioni della meghillat Esther (in quanto “libro” del Tanakh, non in quanto “rotolo” a uso liturgico per celebrare la festa di Purim), ho definito la storia che vi è narrata con questi tre aggettivi: prima ambigua, poi tragica e infine euforica. In questo preciso ordine. Prima ambigua, perché l’iniziale contesto (il banchetto del re Achashverosh in cui scorre abbondante vino) è un consesso di potenti senza remore morali, e l’interpretazione rabbinica della figura di Washtì sintetizza questa ambiguità; ma anche Hadassa/Esther è figura ambivalente proprio nel suo starsene assimiliata cioè “nascosta”, mentre il primo segnale di ebraicità è dato da Mordechai che si rifiuta di inchinarsi e prostrarsi dinanzi ad Haman. Poi tragica, per le trame del perfido ed empio Haman che pianifica lo sterminio degli ebrei di Persia e convince il re che questo è per il bene del suo Stato (primo esempio di antisemitismo politico, diverso nelle motivazioni dalle politiche demografiche di Faraone in Egitto al tempo di Mosè). Infine euforica, quando le sorti si capovolgono e gli ebrei festeggiano con grande esultanza, e a loro volta con molto vino, la salvazione dal decreto di sterminio e “appendono” Haman al posto che questi aveva destinato all’ebreo Mordechai. Middà ke-neghed middà, misura per misura, o per dirla con Hillel (Avot II,6): «Poiché annegasti [altri], fosti annegato [a tua volta]».


Un altro sopravvissuto, Elie Wiesel, ha una reazione non troppo dissimile. Scrive: «Personalmente non ho mai capito questo epilogo. Dopotutto la catastrofe non ha avuto luogo, neppure un ebreo è stato ucciso; allora perché questo spargimento di sangue persiano? (…) È vero, c’erano stati combattimenti e gli ebrei dovevano difendersi contro nemici fanatici e pieni di odio». Ricordo che Wiesel è morto nel 2016, e quindi non si sta parlando di Gaza! Lo scrittore e Premio Nobel continua nel suo commento a Esther: «Ma il testo parla di vendetta, e questo mi sfugge. Qual è il rapporto tra carneficina e miracolo? Come possiamo festeggiare la sopravvivenza dei nostri in mezzo a tanti morti? È questa la ragione per cui dobbiamo bere fino a essere ubriachi? Perché è più facile dimenticare? Per cancellare il confine tra l’immaginario e il vissuto, e pensare che era solo un incubo? Per superare la nostra frustrazione? Un giorno all’anno, il giorno di Purim, ci è permesso di celebrare azioni di una violenza inaudita per ricordarci che è proibito in tutti gli altri giorni dell’anno?». Aggiungiamo poi che il silenzio divino, di un Qadosh barukh Hu mai nominato nella meghillà, aggrava persino la (nostra) situazione… O forse è proprio questa la chiave, la soluzione ai nostri dilemmi? Se Wiesel non aveve scritto quel che ho sopra riportato, chi avrebbe avuto la chutzpà di porre tali domande?
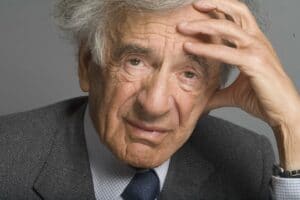
Io penso che la (narrazione della) distruzione di Haman e dei nemici resta essenziale alla conclusione della storia di Esther, anche se tocca a ogni generazione decifrarne il significato. Vi è un male che non può essere riassorbito nel bene, perché incapace di trasformarsi, di fare teshuvà. E c’è un buio che non vuole la luce, e davanti al quale la luce resta impotente e, pertanto, inutile. Lo dice Emmanuel Levinas, non io. Ma trovo che l’ultima parola della meghillat Esther non stia nella meghillà stessa, quanto piuttosto nel Talmud (Gittin 57b; Sanhedrin 69b; dunque è detto in due luoghi diversi) là dove leggiamo che, secondo i maestri di Israele, «alcuni discendenti di Haman studiarono Torà a Benè Braq». Sorprendente! Credo questa sia la miglior vendetta, la vera e più radicale rivincita del giudaismo contro i suoi nemici. O, come dice ancora Levinas: è la giustizia al di là della giustizia. Chag Purim sameach.



