Il paese ha smarrito il suo capitale sociale
Franco Pavoncello legge i tempi di crisi che viviamo come l’effetto di un’onda nata almeno 40 anni fa, il cui approdo sembra (per ora) il governo più a destra nella storia del paese
Prof. Pavoncello, da poco la John Cabot University, di cui lei è rettore, ha festeggiato i 50 anni. Dal suo punto di osservazione, che idea hanno gli Stati Uniti del nostro paese?

Secondo me l’Italia oggi non è particolarmente al centro dell’attenzione degli Stati Uniti; tant’è vero che l’ambasciatore a Roma è rimasto vacante per circa tre anni. Tuttavia, credo che ci sia stato interesse all’inizio nei confronti del governo di centrodestra, quando si è cercato di comprendere che posizioni avrebbe avuto nella guerra in Ucraina, in questo momento al centro dell’attenzione dell’amministrazione americana; mi pare che, sotto questo profilo, gli USA siano stati molto rassicurati.
Nel suo ultimo saggio su Aspenia lei evidenzia il deficit di capitale sociale che in questo momento soffre il nostro paese. Di cosa si tratta?
Devo partire da una premessa: fino agli anni 70 la scienza politica americana aveva l’idea che in Italia la democrazia non avrebbe attecchito bene. Si trattava chiaramente di un’interpretazione troppo negativa, sfatata dagli errori e anche o grazie ai lavori di Robert Putnam con i suoi studi sulle istituzioni regionali italiane, che tra l’altro lo hanno reso uno dei più importanti scienziati politici del ventesimo secolo. Putnam si è incentrato soprattutto sullo studio delle Regioni italiane, io lo ebbi come professore all’università del Michigan e poi lo raggiunsi ad Harvard per realizzare lo studio che ancora oggi viene considerato un fondamentale mezzo per comprendere il formarsi della democrazia italiana.
Può autarci a comprendere meglio?
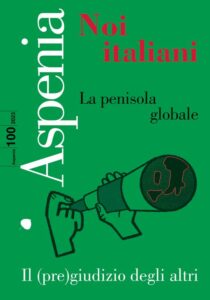
Putnam studiò le Regioni italiane perché si trovava nel nostro paese proprio nel periodo in cui queste cominciavano ad operare concretamente. Un’occasione unica per studiare la genesi di una istituzione politica. Putnam intervistò i primi consiglieri regionali di sei Regioni, suddivise fra nord centro e sud; io fui coinvolto nello studio dell’analisi statistica dei dati, diventando poi uno dei quattro firmatari dell’articolo iniziale della ricerca. Quello che Putnam ha mostrato è che il livello di performance dei governi regionali negli anni 70 e 80 dipendeva direttamente dal livello di fiducia sociale che sussisteva tra le persone, e la capacità di autogoverno delle regioni era più forte dove maggiore era la coesione sociale, la capacità di fare squadra e stare insieme a più persone. Dove al contrario si registravano punte più alte di alienazione e sfiducia sociale, cioè tra individui, le performance delle istituzioni regionali erano più basse, con evidenti ricadute negative sullo sviluppo economico del territorio. In altre parole, il capitale sociale può essere definito il livello di fiducia e collaborazione che sussiste nella società civile, e che dal basso si sposta verso l’alto.
Può fare un esempio?
Un caso di scuola era l’Emilia Romagna, così provata in questi giorni. Come è noto il Nord Italia ha una lunga tradizione di governi comunali, mentre al sud si registrano economie latifondiste basate su un accentramento autocratico. Per Putnam questo spiega gran parte del divario fra nord e sud; inoltre il gap storico rende difficile cambiare le cose.
Cosa può rendere carente di capitale sociale un paese, e cosa al contrario può arricchirlo?

Si tratta di un valore che si costituisce nel corso di decenni se non di secoli. Ci deve essere fiducia nelle istituzioni, e queste a loro volta devono mostrarsi capaci di rafforzare la coesione sociale. Se la struttura di governo coinvolge le persone, allora il capitale sociale aumenta. Se nella gestione della società e nel controllo dei governanti c’è trasparenza, allora si innesca un circuito virtuoso; se, al contrario, manca la collaborazione, se l’élite sono autocratiche e il sistema clientelare, allora il capitale sociale si perde perché le persone preferiranno non collaborare fra loro, ma farsi concorrenza per collegarsi direttamente a chi gestisce il potere, sperando di ottenerne in cambio favori. Con Putnam elaborammo un modello matematico e statistico a riguardo, e abbiamo scoperto che la variabile più importante per spiegare le performance più elevate dei governi regionali era il voto socialista nel 1921, un indicatore della mobilitazione sociale dal basso.
Ci può spiegare il collegamento?

Quella data è l’ultima prima dell’avvento del fascismo, con elezioni tutto sommato libere. Ebbene, nei territori in cui gli elettori avevano scelto il partito socialista, a distanza di mezzo secolo si realizzavano performance più elevate. A nostro avviso la risposta non era nella buona amministrazione del PCI, che in quelle terre a lungo ha governato, ma al contrario la sussistenza di una forte tradizione civica. Infatti, quando poi il partito comunista è arrivato al sud, il modello virtuoso delle Regioni amministrate al Nord non si è ripetuto.
Un grande dibattito nel nostro paese è proprio quello della ricetta per ammodernare il sud e ridurre il divario che lo separa dal resto del paese. Che applicazioni pratiche ebbe la ricerca di Putnam?

Se si guarda la storia italiana, io credo che i fattori che individuammo allora servano a elaborare una diagnosi ancora oggi attuale. Sabino Cassese, individuato dal ministro Calderoli responsabile della commissione che deve elaborare l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), strumento fondamentale per garantire il welfare state e livelli omogenei di tutela sociale, in effetti ha proprio citato il lavoro di Putnam all’inizio del proprio mandato. Inoltre, la ricerca fu applicata anche negli Stati Uniti.
Con quali risultati?
Il risultato fu che, alla fine degli anni 60, inizi degli anni 70, l’impegno civico, e il capitale sociale, erano crollati. Il paese era cresciuto molto nei decenni precedenti grazie alla fiducia reciproca che sussisteva fra i cittadini, perché quello era ancora il paese dove forti erano ancora i corpi intermedi che già Alexis de Tocqueville aveva descritto agli inizi dell’Ottocento. Alla metà del XX secolo gli USA avevano conosciuto elevati tassi di crescita economica perché dal basso, dalle periferie, erano cominciate a cambiare le cose. Le faccio solo un esempio: la nascita dei licei aperti a tutti, fondamentali per far nascere la middle class, è una novità di quegli anni. Il crollo di capitale sociale invece si registra a partire dalla morte del presidente Kennedy e con la rivoluzione di fine anni 60. Il paese cominciò una sua involuzione che portò Putnam alla fine del secolo scorso a pubblicare il libro “Bowling alone” che lo rese famoso, in cui si fotografava una realtà americana sempre piu’ formata da individui soli e sempre meno parte di gruppi o associazioni. Sempre più gente gioca a bowling ma sempre meno in squadre. Basti pensare che ormai l’80 per cento delle famiglie americane non cena più insieme. Putnam ha citato un dato importante. Appartenere a un solo club riduce della metà la probabilità di morte. Dato empirico incredibile.
Torniamo in Italia. A cosa dobbiamo l’attuale declino di capitale sociale italiano?
In Italia registriamo una grande impennata di fiducia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il fascismo aveva creato una cesura con la società liberale dell’Ottocento, per cui fu merito dei leader del momento – De Gasperi, Togliatti, Nenni, Parri – ricostruire il paese, anche dal punto di vista della visione storica, sostenendo la fiducia nelle nuove istituzioni repubblicane e rafforzando la volontà di ricostruire il paese. Se studiamo gli indici di fiducia, ci rendiamo conto che nel dopoguerra, fino agli anni 60, la popolazione italiana mediamente ha un’upswing, ossia una grande fiducia nel governo, certamente molta più che dopo quel periodo. A partire dalla metà, forse dalla fine degli anni 60, al contrario, anche noi come gli Stati Uniti subiamo un calo, dovuto a un aumento dei conflitti sociali e a una maggiore individualizzazione, che porta come conseguenza una polarizzazione politica. Per arrivare alla storia più recente, tangentopoli ha determinato un ulteriore calo del capitale sociale, perché al precedente sistema politico, decapitato dalle inchieste della magistratura, se ne è sostituito un altro più debole, che non ha saputo ricostruire il capitale sociale nel frattempo perduto.
Come intervenire per il risveglio dei corpi intermedi e aumentare la fiducia e la collaborazione sociale?

L’interazione tra società civile e politica è fondamentale. Giovanni Sartori ad esempio sostiene che la politica modella la società, una visione un po’ gramsciana, quella del partito principe. Io direi piuttosto che società civile e società politica camminano insieme. Le élites politiche, intellettuali, amministrative non devono muoversi da sole, piuttosto devono promuovere riforme e fare buon governo, perché è dimostrato che questo produce una risposta positiva da parte della popolazione. La struttura sociale di un paese incide sul comportamento degli individui, come ci insegna la teoria dei giochi.
A suo avviso le politiche sociali ed economiche del governo Meloni vanno nella direzione auspicata a favore del capitale sociale?
Io credo che ci siano alcune considerazioni preliminari da fare. Innanzitutto, occorre essere consapevoli che senza risorse adeguate il cambiamento non può essere avviato. Se guardiamo agli Stati Uniti, sappiamo che quello è un paese con grandi risorse disponibili, noi al contrario siamo un paese fortemente indebitato. Inoltre dobbiamo anche considerare che quello di Giorgia Meloni è un governo di coalizione. Terzo, ma non ultimo, dobbiamo guardare la relazione fra forze politiche e pezzi della società civile.
Cosa intende?

Mi sembra evidente che il potere politico in Italia, da molto tempo, sia molto debole rispetto ad interessi espressi da alcune parti della società.
Può fare qualche esempio?
Guardi la riforma mancata della concorrenza, o anche la riforma mancata della burocrazia. Servirebbe un governo con una forza sufficiente per avviare delle riforme senza paura di crearsi inimicizie. In questo momento tuttavia la politica italiana è sempre concentrata sul breve periodo, per cui in questa situazione non si può pensare a realizzare dei cambiamenti in grado di produrre il circolo virtuoso di cui avremmo bisogno.
Quindi assolve il governo da ogni responsabilità?

Dico che la debolezza del sistema politico non nasce certo oggi. Anche in passato ne siamo stati afflitti, guardi all’uso dei governi tecnici, con figure prese per lo più in prestito dalla Banca d’Italia: Ciampi, Monti, Dini, Draghi. Lo sfaldamento dei partiti di massa ha aperto le porte a un nuovo populismo, con conseguente deterioramento della classe dirigente.
Tutto questo come incide su Fratelli d’Italia, sulla sua capacità di governare il paese?
Il partito di Giorgia Meloni ha un’evidente problema: non è stato mai al governo, e ha avuto una forza elettorale sempre bassa. Il risultato è che non ha potuto selezionare in tempo una classe dirigente adeguata, e questo oggi probabilmente è un prezzo che paga nella guida del governo.
Un’altra questione è poi quella delle radici di Fratelli d’Italia, ossia il suo legame con il movimento sociale italiano, e dunque il problema della piena accettazione dei valori della nostra costituzione.

Certamente Fratelli d’Italia ha una tradizione politica che la riporta indietro direttamente al movimento sociale italiano. Io credo però che qui le considerazioni siano molteplici. Ritengo infatti che ogni classe dirigente che va al governo, assumendo una responsabilità di fronte al paese, ma anche nei confronti della comunità internazionale, sia inevitabilmente condizionata dall’enorme responsabilita’ che si assume. Inoltre io penso che ormai la nostra costituzione repubblicana abbia assunto il ruolo di fulcro per l’identità del paese. Infatti la storia ci mostra che chi in passato ha messo in discussione questo perno fondamentale è andato piuttosto velocemente fuorigioco. Se il sistema politico italiano ancora ha una forza, è quello di essere nato sulle ceneri di una monarchia liquefatta, grazie a una classe dirigente che ha permesso di costruire il paese e creare una democrazia con profonde radici popolari. Io credo che oggi tutte le forze del sistema politico partano da questa considerazione.
In passato l’ebraismo italiano è stato di grande aiuto alla costruzione dell’identità nazionale. E oggi?

L’ebraismo italiano è una comunita’ abituata all’autogoverno, sulla base della propria tradizione millenaria. Per loro natura gli ebrei, attraverso la religione, ma anche le istituzioni comunitarie, sono da sempre allenati alla democrazia, e prestano da sempre grande attenzione alla collaborazione. Prenda ad esempio la storia dei ghetti: se non era capitale sociale quello! Nei ghetti non si poteva sopravvivere senza collaborazione. E poi dobbiamo ricordare l’anelito alla libertà che da sempre alimenta la cultura ebraica, e che dopo 2000 anni di persecuzioni ha portato gli ebrei italiani in particolare a riconoscersi nell’ideale mazziniano e a dare un grande contributo di libertà per costruire lo stato italiano. Anche in età repubblicana le istituzioni hanno riconosciuto questa forza culturale del mondo ebraico italiano, che si è espressa in figure come Tullia Zevi, Elio Toaff, e oggi Riccardo Di Segni o la Senatrice Segre, per citare dei nomi importanti. In generale direi che il pensiero ebraico ha un continuo anelito alla giustizia e alla compassione. Se guardiamo la storia d’Italia, la partecipazione degli ebrei alle guerre di indipendenza fu altissima, e anche dopo la guerra il rapporto con il mondo ebraico è stato da sempre una cartina di tornasole per giudicare non solo l’integrazione di un gruppo minoritario, ma anche il livello di democraticità dell’intero paese.
Lei ha studiato, tra l’altro, all’università di Gerusalemme e conosce Israele, oltre che gli Stati Uniti e l’Italia. A suo avviso l’approccio ebraico nel modo di leggere i fenomeni sociali o di parteciparvi, può fornire elementi utili per l’aumento di collaborazione nella società?

In generale, il senso di comunità e l’importanza data allo studio, nonché il principio caro agli ebrei per cui ciascuno è responsabile degli altri, sono tutti principi che si traducono in un continuo impegno civico, ossia in uno sforzo per il miglioramento della società.
Eppure, se guardiamo la situazione di Israele oggi, si potrebbe mettere in discussione questa capacità di rafforzare la coesione sociale.
Per quanto riguarda Israele, la situazione è davvero molto complicata, però credo che quello che vediamo ci permetta anche di individuare elementi positivi. Di fronte alla messa in discussione dei valori fondamentali dello Stato democratico, la società civile reagisce con una grande spinta alla tutela di quei valori. Certo, occorre considerare anche il cambiamento demografico in corso: nel 1948 in Israele c’erano 40.000 religiosi, oggi sono circa un milione e mezzo. Io credo che le dimostrazioni di queste settimane siano un esempio di un paese che non vuole disperdere il proprio capitale sociale, ma che al tempo stesso non può permettersi un indebolimento della sua sicurezza; Israele, infatti, non ha la fortuna di altri paesi, di aver conosciuto un’esistenza per lo più di pace.





Una risposta
Ringrazio personalmente il Prof. Pavoncello per questa chiara ed illuminante intervista. Ritengo però, che, l’occupazione, la tranquillità economica di un Paese e la sua capacità di intervenire con ammortizzatori sociali, siano alla base del mantenimento del “capitale sociale”, così come inteso, ricordando che l’Italia del dopoguerra si risollevò, solo grazie a quella grande siringa di aiuti economici che fu il Piano Marshall. Su come poi questi furono spalmati tra Nord e Sud, è un’altra storia…