La mia vita…insider Vaticano (prima parte)
Lisa Palmieri-Billig racconta a Riflessi la sua esperienza come giornalista e inviata del mondo ebraico americano presso la Città del Vaticano
Lisa, da molti anni, come giornalista e come rappresentante accreditata dell’American Jewish Committee in Vaticano, segui le vicende della Chiesa cattolica. Per cominciare, mi piacerebbe chiederti qualcosa di te, nata a Vienna, ma nel 1938 costretta a fuggire negli Stati Uniti.

Vengo da una famiglia di ebrei viennesi scampati all’Olocausto grazie alla lungimiranza di mio padre Fritz, esperto filatelico che viaggiava spesso per lavoro. Nella primavera del 1938 andò a Cuba per ottenere visti per gli USA. Avevo due anni, e con i miei genitori emigrammo a New York, nell’estate tra l’Anschluss e la Kristallnacht. Crescendo a New York, non ho vissuto direttamente l’antisemitismo, ma vedevo le lacrime di mia nonna ogni volta che arrivava posta dall’Europa, e ho ascoltato i ricordi degli esuli mitteleuropei della “Classe del ’38” quando stavamo tutti insieme ai pranzi viennesi preparati dai miei a casa nostra a Jamaica, Queens. A 15 anni, ho scritto una recensione per il giornale del mio liceo su “L’ultimo dei giusti” di André Schwarz-Bart, un libro che mi ha profondamente commosso e ha determinato il mio impegno vita durante per il “Mai più”.

Nel 1961, sono venuta a Roma per insegnare alla American Overseas School of Rome, poi ho lavorato all’ORT e all’ufficio del World Jewish Congress a piazza di Spagna, dove, come “segretaria e stenografa” del direttore Fritz Becker, responsabile insieme a Gerhardt Riegner delle relazioni con il Vaticano durante il Concilio, ho iniziato a comprendere le ragioni storiche e tragiche dell’intenso interesse ebraico alla stesura del nascente “documento sugli ebrei” che diventò “Nostra Aetate”. Nel 1965 ho scritto il mio primo articolo per il “Jerusalem Post” sulla rocambolesca storia di Mordechai Louk, una spia israeliana trovata legata e imbavagliata nel bagagliaio dell’auto di un diplomatico egiziano davanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, in procinto di essere imbarcata su un volo per il Cairo, e questo diede il via ai miei 50 anni come corrispondente da Roma e dal Vaticano del Jerusalem Post e altra media internazionale; oggi scrivo in inglese e in italiano principalmente per “Vatican Insider”, il supplemento online de “La Stampa”. Dal 1988 al 2004 sono stata la rappresentante dell’ADL (Anti Defamation League) a Roma e nel 2005 sono passata all’AJC (American Jewish Committee) come “Representative in Italy and Liaison to the Holy See”, per occuparmi delle relazioni interreligiose più vaste e alla difesa diplomatica di Israele, e della sicurezza e benessere della diaspora ebraica.

Innanzitutto bisogna ricordare che per i primi quasi 50 anni della sua esistenza, l’uso della parola “Israele” era tabù nel Vaticano. Si parlava semplicemente della “Terra Santa” dai confini incerti. Il tacito divieto, si ipotizzava, era dovuto all’antico pregiudizio teologico risalente al 1904, quando Pio X rispose così al sogno sionista di Theodor Herzl: “Dal momento che non riconoscete Gesù Cristo come nostro Signore, noi non possiamo riconoscere uno Stato ebraico”. Col passare degli anni il motivo fu aggiornato, come rivelò il portavoce vaticano Joaquin Navarro Valls dopo quasi un secolo. Durante una conferenza stampa del luglio 1992 fu annunciata la creazione di una Commissione bilaterale Israele-Vaticano. Alla domanda di un giornalista che metteva in dubbio la saggezza politica della mossa, Joaquin affermò seccamente: “I palestinesi e gli altri arabi non possono protestare contro il nostro avvio di un processo diplomatico che porti al riconoscimento diplomatico di Israele, quando loro stessi sono ora seduti al tavolo dei negoziati a Madrid con le autorità israeliane” (cioè la Conferenza di pace di Madrid). Tuttavia, ancora oggi le reazioni del mondo arabo hanno un loro peso sulle scelte politiche del Vaticano.
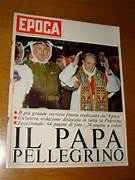
Nel 1964, Paolo VI fu il primo Papa della storia a visitare Israele, e al suo ritorno scrisse un biglietto di ringraziamento semplicemente al “Signor Ephraim Shazar, Tel Aviv”. Ma già tredici anni dopo, il 31 luglio 1977, lo stesso pontefice fece una richiesta ufficiale al “Presidente Ephraim Katzir, Gerusalemme” chiedendogli di concedere la grazia presidenziale a monsignor Hilarion Capucci, capo della Chiesa greco-cattolica di Gerusalemme Est e della Cisgiordania, che stava scontando una pena di 12 anni per contrabbando di armi e collaborazione con gruppi terroristici: era stato arrestato nel 1974 mentre guidava da Gerusalemme a Nazareth con un carico di armi ed esplosivi. La richiesta fu accolta. Dopo questo episodio, le relazioni tra Vaticano e Israele si sciolsero leggermente, ma i riconoscimenti diplomatici non erano ancora ufficialmente all’orizzonte.
I progressi nel dialogo interreligioso erano una premessa necessaria per l’instaurazione di relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. Dalla conclusione del Concilio Vaticano II con la pubblicazione di Nostra Aetate nel 1965, nelle relazioni cattolico-ebraiche si è verificata una rivoluzione notevole, in un periodo storico straordinariamente breve, considerando il passato con le due millenni di storia turbolenta e periodicamente tragica. Il documento ha anche aperto le porte alle future relazioni con lo stato di Israele.


Quando il rav David Rosen ed io fummo ricevuti privatamente da Giovanni Paolo II ad Assisi durante la preghiera per la pace in Bosnia scoprimmo le nostre comuni radici polacche ancestrali nella zona intorno a Cracovia. Ricordando l’Olocausto, lo sguardo di Papa Wojtyla divenne improvvisamente molto serio e intenso e ci disse: “Dobbiamo lavorare insieme per garantire che nulla di simile accada mai più!”.
Benedetto XVI ha portato avanti in maniera leale e sincera questa nuova pagina di storia. Dopo il suo discorso a una conferenza internazionale a Gerusalemme su “Leadership religiosa in una società secolare”, mi ha detto che “Israele ha diritto a questa terra”. La dichiarazione è stata pubblicata sulla rivista “Studi Cattolici”. Devoto studioso di teologia, impegnato ad approfondire la comprensione con gli ebrei, è stato forse ingiustamente sottovalutato perché gli mancava il carisma di Papa Wojtyla e l’esperienza di vita, di amicizia personale, con gli ebrei. Sentiva un profondo legame con Israele. Una mia intervista con lui pubblicata contemporaneamente in Italia da “Studi Cattolici” e negli Stati Uniti dalla rivista ebraica “Midstream”, ha rivelato la grande attenzione che ha applicato, nella sua supervisione della stesura del nuovo Catechismo Universale, per evitare l’uso di ogni possibile residuo di antisemitismo teologico. Se si può caratterizzare il carattere dei papati del dopo Consiglio con una sola parola ciascuno, si potrebbe dire che quello di Giovanni Paolo II era “politico”, quello di Benedetto XVI “teologico” e quello di Francesco “pastorale”.

Innanzitutto bisogna ricordare che le ferree, benché non scritte, regole della diplomazia vaticana richiedono equilibrio ed equidistanza constanti di fronte ad ogni conflitto, per far sì che la Chiesa rimanga fedele all’aspirazione di essere un equo mediatore per la pace. Per Papa Bergoglio, questa tradizione è un aspetto essenziale del suo impegno. Questi, insieme alle considerazioni per la sicurezza e la sopravvivenza dei fedeli del cattolicesimo e delle sue istituzioni in tutto il mondo, sono stati i principi guida della diplomazia vaticana nel corso dei secoli. Hanno giocato un ruolo importante nella politica vaticana durante la Seconda Guerra Mondiale e lo fanno anche oggi. Malgrado recenti episodi di parole dette e scritte, alle volte considerate controverse o almeno malintese, i leader ebraici della diaspora e di Israele impegnati nel dialogo interreligioso (compreso l’AJC), continuano a considerare Francesco fondamentalmente come amico del popolo ebraico. Francesco ha ripetutamente espresso profonda empatia e affettuosa sensibilità per tutte le parti in causa in questo conflitto. I parenti israeliani degli ostaggi, il soldato israeliano ferito e altre persone sofferenti che lo hanno incontrato durante questo tragico conflitto, hanno tutti testimoniato il calore e la compassione umana che trasmette.

Ad ogni modo, seguendo le famose regole non scritte del Vaticano, Francesco evita discussioni sulle cause lontane o immediate del conflitto. Non fa mai riferimento alle preoccupazioni riguardanti la possibilità di una rapida vittoria delle forze islamiste che avrebbe conseguenze gravissime per Israele e per il mondo intero. Coloro che non hanno subito il lavaggio del cervello da parte della propaganda di Hamas, che purtroppo è stata ben confezionata, si rendono conto che la lotta di Israele per la propria sopravvivenza si estende alla lotta per la sopravvivenza di tutta la civiltà occidentale. Questo compito ricade oggi sulle sole spalle di Israele, mentre secondo tutti i comuni standard etici dovrebbe essere giustamente sostenuto dall’intero mondo libero in una diplomazia unita. Questa sfida, ovviamente, supera i confini della tradizionale attività vaticana. C’è da chiedersi, però, quanta consapevolezza ci sia dell’impellente necessità di tale unità. Infine, Francesco continua a mettere in guardia contro il crescente antisemitismo e sostiene le riforme del Concilio Vaticano II. I suoi ripetuti appelli alla pace sono oramai sempre accompagnati da richieste di liberazione degli ostaggi. Infine, l’ultimo episodio intorno al dono palestinese da Betlemme di un presepio col bambino Gesù adagiato sulla keffiah ha lasciato perplessità ancora da chiarire. L’importante è che grazie all’impegno post-conciliare da ambedue le parti, oggi il dialogo può continuare con franchezza, rispetto, ascolto e fiducia reciproco, un risultato notevole.





4 risposte
Grazie, una interessantissima intervista, anche se ritengo che quanto Papa Francesco abbia detto e scritto dal 7ottobre in poi, non abbia prodotto un effetto del tutto bilanciato verso l’esterno e soprattutto verso il mondo cattolico.
Commento di arbib eccellente da condividere
Grazie, attendo con vivo interesse il seguito dell’articolo
Come semplice cattolica, impegnata da quasi trent’anni con tutto il mio cuore e con tutte le mie forze nell’amicizia ebraico-cristiana, credo nel futuro di questo dialogo che è costitutivo dell’identità stessa dei cristiani. Nonostante il retaggio di un lungo passato storico, da cui la cristianità sta prendendo ma deve ancora continuare a prendere le distanze, assieme alla drammaticità dei tempi presenti, ormai i legami con gli ebrei sono imprescindibili per essa a causa soprattutto “della forza sorprendente dei legami spirituali che uniscono la Chiesa di Cristo al popolo ebraico” (card. J. Ratzinger nella prefazione a “Il Popolo Ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia Cristiana” della Pontificia Commissione Biblica, 2001).