Avraham avinu- Abramo nostro padre
Rav Gianfranco Di Segni risponde a un commento intriso di pregiudizi antigiudaici del teologo Vito Mancuso
Vito Mancuso è un teologo giovane, che da anni trova spazio in fiere, festival, saloni letterari. Di sé cura l’immagine di uomo di fede aperto alla modernità, critico della Chiesa curiale, in dialogo continuo e progressista con la società. Chissà allora gli altri, verrebbe da dire, leggendo il suo pensiero, intriso di ignoranza e pregiudizio. Ancora una volta, parlando di ebraismo, emergono stereotipi e cliché antigiudaici.
Riflessi pubblica al riguardo il commento di rav Gianfranco Di Segni, scienziato, direttore della Rassegna mensile di Israel e docente al Collegio rabbinico italiano.

Sul Venerdì di Repubblica del 3 marzo 2023 (n. 1824), in un’intervista su Lucio Dalla, Vito Mancuso racconta di essere stato chiamato ai suoi funerali a leggere in chiesa un passo della Genesi: «Un doppio strazio. Un brano della Bibbia che non sopporto: Genesi 22, il sacrificio di Isacco, uno dei passi più terribili. Un modello di fede, quella di Abramo, che io non tollero». E ancora: «Un Dio che ti dà un coltello per scannare un figlio. La fede come obbedienza senza criterio, anche quando l’etica viene calpestata».
Mi chiedo: ma se fosse vera questa lettura del passo come qui presentata, se fosse vero che quello di Abramo è un modello di fede che non si può tollerare, come è possibile che si riconosca in Abramo il padre delle tre religioni monoteistiche, dette appunto abramitiche? Metà circa dell’umanità è figlia di un padre omicida e scriteriato?

Capisco che un’intervista in un magazine non è il luogo per riflessioni teologiche e bibliche approfondite, ma i lettori leggono le parole riportate dal Venerdì e si fanno un’idea del tutto sbagliata del passo biblico. A iniziare dal concetto di “sacrificio di Isacco”, espressione estranea alla tradizione ebraica, dove si parla di “legatura di Isacco”. Isacco fu legato sull’altare, ma non fu sacrificato. Dove sta scritto: «Un Dio che ti dà un coltello per scannare un figlio»? Da nessuna parte. È esattamente il contrario. Quando Abramo sta per alzare la mano sul figlio, Dio lo ferma e gli dice: «Non alzare la mano sul ragazzo e non fargli nulla». Dove sta scritto che Dio dice ad Abramo di scannare suo figlio? C’è invece scritto «fallo salire sul monte» (come bene spiega il commentatore per eccellenza, Rashì), con un’espressione volutamente ambigua per appurare se Abramo avesse capito il reale significato delle parole divine. Tutto il brano viene a insegnare ad Abramo e a tutti i suoi discendenti che è vietato sacrificare essere umani (come verrà più volte ribadito in seguito nella Torà, per esempio in Deuteronomio 18:10), pratica comune fra i popoli pagani dell’epoca. È questa cultura pagana e omicida che la Torà viene a negare, esattamente il contrario del messaggio che esce fuori dal Venerdì.

Abramo «senza criterio»?! Eppure l’abbiamo visto discutere con Dio per la salvezza degli abitanti di Sodoma e Gomorra ed esclamare: «Il Giudice di tutta la terra non farà giustizia?» (Genesi 18:25). Possibile che qui stia zitto e obbedisca supinamente? Dio gli ha promesso che la sua discendenza continuerà con Isacco: possibile che non si chieda come ciò sarà possibile se sacrificherà il figlio? Abramo cammina per tre giorni e non proferisce parola. Possiamo immaginare che si stia facendo queste domande e stia cercando di darsi una risposta (e infatti il Midrash riempie il silenzio con queste domande). Quando finalmente Isacco gli chiede: «Padre mio, ma dov’è l’agnello?», Abramo risponde: «Figlio mio, Dio provvederà l’agnello». Come in effetti avvenne.
Abramo aveva fiducia nel fatto che il Giudice di tutta la terra avrebbe fatto giustizia. Aspettava con ansia che arrivasse il comando di Dio di fermare la mano. La prova a cui Abramo fu sottoposto era arrivare a capire che non si sacrificano i figli (o chiunque altro), anche quando si crede di aver sentito una voce, dentro di sé o fuori di sé, che lo ordini. La prova era capire che dei due ordini apparentemente contraddittori, il secondo – quello di non fare nulla al ragazzo – era l’ordine corretto e definitivo.
Se si fraintende il messaggio biblico nel caso di Isacco, dove vediamo che al padre viene impedito da Dio di alzare la mano sul figlio, a maggior ragione c’è il rischio che lo si fraintenda quando è Dio stesso che sacrifica il figlio, come nella fede cristiana.
Sono stati usati fiumi di inchiostro da parte di decine di commentatori, teologi, filosofi, ebrei e non ebrei, per spiegare questo passo della Genesi, che avrebbe meritato di più della lettura superficiale apparsa sul Venerdì.
Rav Gianfranco Di Segni



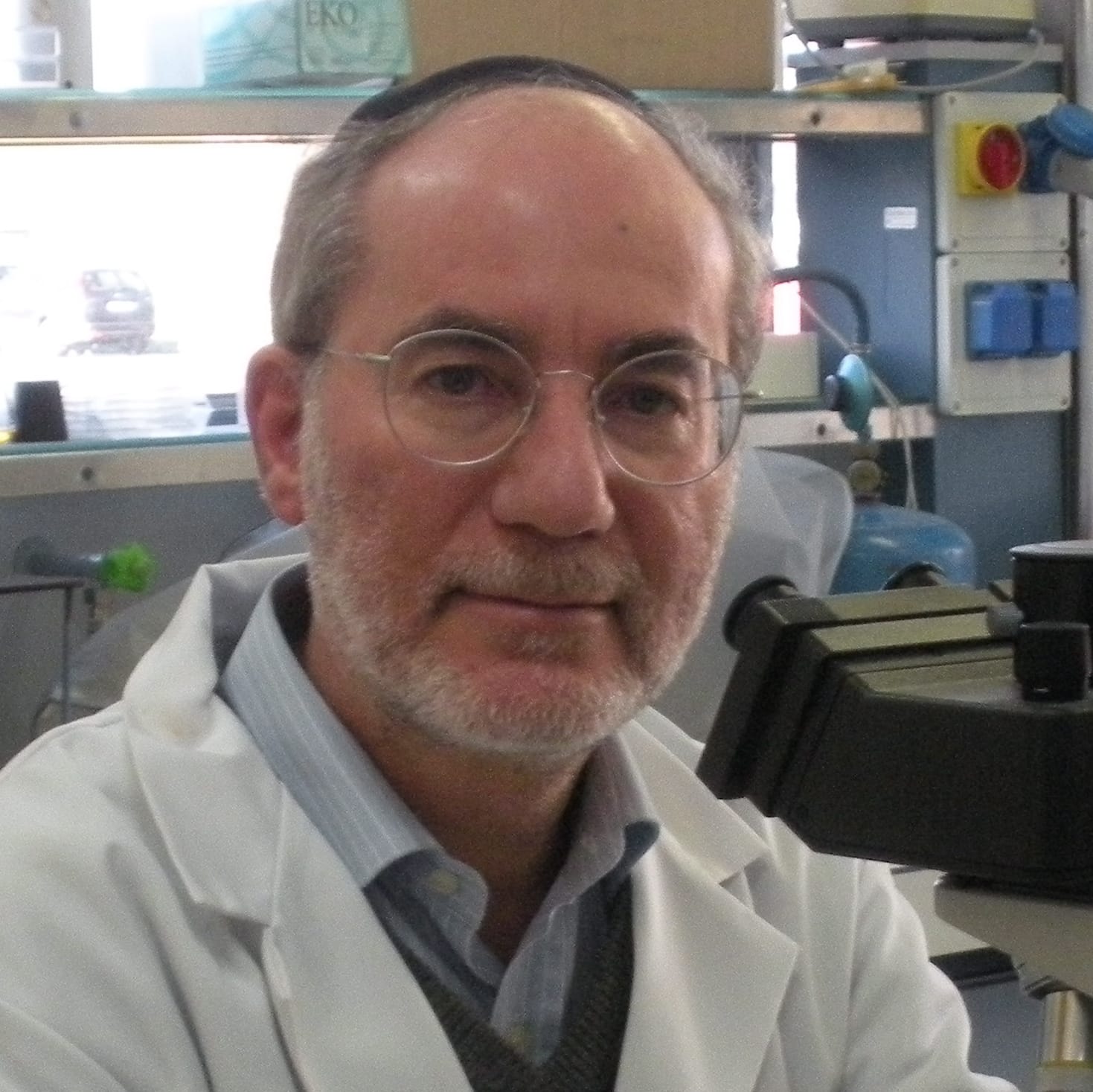
6 risposte
La conclusione è che bisogna diffidare dai teologi cosiddetti progressisti!
Ratzinger non avrebbe mai scritto un giudizio così superficiale!
Da sempre ritengo l’antisemitismo una delle manifestazioni più volgari e pericolose della malignità umana e credo che la lotta contro di esso sia dovere fondamentale di ogni essere umano degno di questo nome. Anche per questo da quando ho iniziato a guidare gruppi in Israele lo Yad Vashem è tappa obbligata. Aggiungo che mi sono nutrito del pensiero e della spiritualità ebraica da quand’ero ragazzo, a partire dalla Bibbia naturalmente e poi di autori il cui elenco sarebbe troppo lungo e che accompagnano ancora oggi il mio cammino. Per questo sono rimasto stupito, ma sarebbe meglio dire addolorato, nel vedere il mio pensiero etichettato come “intriso di pregiudizi antisemiti”. È quanto si legge qui, a commento redazionale dell’articolo di rav Gianfranco Di Segni. Ora attenzione: Di Segni critica il mio pensiero (anche tramite mai che ci scambiamo), ma è ben lungi dall’accusarmi di antisemitismo o di antigiudaismo, come invece fa la questa redazione della che mi attribuisce “pregiudizi antisemiti”, “ignoranza e pregiudizio”, “stereotipi e cliché antigiudaici” (oltre a un tono generalmente malevolo). Il punto che mi sta più a cuore è esattamente questo: l’uso improprio del concetto di antisemitismo. È così importante la lotta contro questo mostro che bisognerebbe essere molto rigorosi con le parole, perché attenzione: se tutti sono antisemiti, nessuno alla fine lo è, e chi ci guadagna sono i veri antisemiti. Non è inoltre ammissibile la confusione (per di più da parte ebraica) tra antisemitismo e antigiudaismo da voi praticata accusandomi ora dell’uno ora dell’altro, perché l’antigiudaismo riguarda le idee religiose, l’antisemitismo il sangue delle persone. È vero che i due concetti sono tra loro collegati e dal professare l’uno è facile transitare nell’altro, ma proprio per questo la loro distinzione contribuisce a impedire l’indebito passaggio. PS: la replica a rav Di Segni è pubblicata su La Stampa del 27 marzo 2023. Altro PS: non sono più giovane, ho 60 anni
Gentile Mancuso,
mi scuso se, nella prima versione on line dell’articolo, la nota redazionale confondeva antisemitismo con antigiudaismo. Come vede ora abbiamo corretto, attribuendole “solo” l’antigiudaismo. Mi scuso anche per averle dato del “giovane”, spero lo prenda come un augurio.
Quanto al resto, purtroppo la sua replica non è convincente. Due mesi fa circa ospitammo l’intervista a un politico nazionale che, pur dichiarandosi sinceramente amico degli ebrei e di Israele, continuava a sostenere che il pensiero ebraico fosse poco più di un tribalismo che si divertiva a lapidare le persone. Spiace constatare che lei, sia pure con argomenti molto più raffinati, dia la sensazione di avere non piena consapevolezza di oltre due millenni di esegesi ebraica al testo. Visto che per sostenere le sue tesi si affida a un romanzo (forse non la fonte migliore, pur amando noi di Riflessi moltissimo Amos Oz), mi permetto di suggerirle un altro testo: Elie Wiesel, “Personaggi biblici attraverso il Midrash”; leggendolo, forse potrà rendersi conto di quanto certi pregiudizi, anche se involontari, siano duri da scalfire. Con cordialità, Massimiliano Boni
Gentile Boni,
anzitutto grazie per le correzioni apportate, anche se il tono di tutti gli interventi redazionali rimane sarcastico e malevolo, a differenza dello scritto di rav Di Segni. Vede, parlando di Bibbia e spiritualità io penso che bisognerebbe esserne all’altezza già a partire dallo stile.
Quanto al merito, mi permetto di segnalarle che non solo io, ma neppure rav Di Segni è d’accordo con Lei, visto che in una mail personale (che io sono ovviamente pronto a esibire) mi ha scritto di ritenere la mia interpretazione certo insufficiente e inaccettabile, ma per nulla intrisa di antigiudaismo. E tanto meno di antisemitismo, ovviamente. Vede, criticare un passo della Bibbia non significa per nulla criticare un’intera religione, e questo lo insegna nel modo più profondo proprio la tradizione ebraica che è così ricolma di criticità e di anche di aspri dibattiti.
Mi permetta di aggiungere un’altra cosa, un consiglio fraterno direi, se mi è permesso: siate molto attenti nell’uso del concetto di antisemitismo, è così prezioso e va tutelato perché non finisca come quel giovane pastore che gridando sempre a sproposito “al lupo al lupo!”, finì per non essere creduto da nessuno quando il lupo un giorno per davvero arrivò. E purtroppo i lupi si aggirano, e noi abbiamo bisogno di raccogliere tutte le forze degli “uomini di buona volontà”.
Anche a Lei i miei più sinceri e cordiali saluti,
Vito Mancuso
Gentile Mancuso,
la pregherei di non esbire nessuna mail privata, perchè non sarebbe corretto verso il mittente. Del resto, conosco da molti anni rav Gianfanco Di Segni, come immaginerà se abbiamo qualcosa di cui parlare siamo usi scriverci direttamente.
Replico molto brevemente a un paio di passaggi della sua risposta. Sullo stile delle mie parole: se sono state dure, e me ne scuso, derivano solo da una certa stanchezza con cui qualche volta si reagisce di fronte a sterotipi che per l’ennesima volta ci troviamo a leggere; quando poi veicolati da figure di una certa notorietà, essi sono ancora più fastidiosi. Ho compreso che il mio stile non le sia piaciuto, me lo fa notare anche stavolta; mi dispiace, certo. Tuttavia, non sono così sicuro che sia indice del “non essere all’altezza”. Il Talmud è pieno di discussioni ruvide e rude tra maestri,e nessuno dice mai all’altro di non essere all’altezza (lei stesso accenna ad “aspri dibattiti”: e dunque, mi verrebbe da chiedere, di cosa si lamenta?). Il secondo punto riguarda il suo criticare o non criticare la religione ebraica. Le controversie tra mestri, come scrive, sono certo una costante nel pensiero ebraico. Il punto, mi pare, è che tutte le discussioni operano all’interno di quel pensiero e di quell’orizzonte; le sue, invece, sembravano provenire dall’esterno. Naturalmente non pretendiamo di essere convincenti con tutti; resto convinto tuttavia che tanti secoli di pregiudizi dovrebbero suggerire più cautela, soprattutto nella parole di chi viene letto da un ampio pubblico. Direi che se questa discussione le potrà suggerire in futuro quella cautela di cui non c’è traccia nell’intervista, avrà raggiunto il suo scopo. Sull’uso dell’antisemitismo non replico: nell’articolo non ce n’è più traccia, e quindi non vedo più ragioni di critica. Grazie, e mi scusi se l’ho fatta più lunga del previsto.
Il richiamo critico di Vito Mancuso al comportamento tenuto da Abramo nell’episodio narrato in Genesi, 22 e il dibattito che ne è seguito sul sito http://www.riflessimenorah.com
ripropongono un tema decisivo, che non riguarda soltanto le tradizioni spirituali che si riconoscono nelle tre grandi religioni monoteistiche. L’inevitabile rapsodicità e schematicità a cui il medium giornalistico costringe (in particolare nella forma dell’intervista) non ha certamente aiutato a individuarlo e ha anzi sovraccaricato la discussione di echi e accenti che credo abbiano «addolorato» tutti gli interlocutori, non solo chi, come Mancuso, apertamente lo confessa. Impegnarsi a liberare il campo dai malintesi che possono essere generati dal contesto in cui le parole sono pronunciate è certamente il primo passo per un dialogo in spirito di verità, ma per cogliere il nucleo problematico reale che a mio parere l’episodio biblico esprime (il rapporto dell’uomo con l’Assoluto) è poi necessario sfrondarlo dall’aggiunta di elementi che attengono a questioni strettamente filologiche e fattuali e anche evitare che il ricondurlo immediatamente all’interno di prospettive esegetiche più ampie e complesse – esercizio certamente legittimo e anzi alla fine auspicabile – abbia l’effetto di stemperarne la portata universalistica e la forza di provocazione radicale che deve avere per ogni spirito in senso lato «religioso».
Nella tradizione spirituale della filosofia, che è quella in cui mi riconosco, la figura di Abramo, che si dispone a sacrificare il proprio figlio Isacco in obbedienza del comando di Dio, ha interrogato nella forma più radicale Kierkegaard, il cui pensiero ruota tutto attorno a questo enigma: «perché Abramo goda onori e gloria come un Padre della fede, mentre dovrebbe essere additato e cacciato come un assassino» (Timore e tremore, 1843). Kierkegaard accoglie con piena consapevolezza la sfida terribile che l’episodio biblico pone alla coscienza religiosa e adopera la storia di Abramo per rappresentare in exemplum l’essenza della fede come «sospensione teleologica dell’etica». Abramo è «un emigrante dalla sfera dell’etica», «ha cancellato con la sua azione tutta l’etica ottenendo il suo telos superiore fuori di essa». Qualificandosi come un paradosso, l’esperienza della fede non può essere comunicata attraverso il pensiero e la parola, e perciò può esprimersi soltanto nel silenzio: «Abramo non può parlare […] poiché parla in una lingua straniera».
La sofferenza e l’angoscia che l’assunzione del paradosso comporta potrebbero trovare un qualche sollievo nel «generale», nella dimensione comunitaria della vita, nell’affidamento alla possibilità di una comprensione da parte degli altri, ma questa prospettiva si presenta al filosofo danese sotto l’aspetto della meschinità e del filisteismo che contrassegna il suo tempo storico ed è rifiutata a vantaggio di un rapporto d’ amore «privato», cioè personale, diretto e senza mediazioni con Dio. Questo amore incondizionato di Dio s’incarna nella figura di Abramo che suscita in Kierkegaard ammirazione e nello stesso tempo spavento. Il paradosso della fede si compendia tutto in questo aut-aut: «O il Singolo come Singolo può stare in un rapporto assoluto all’Assoluto, e allora l’etica non è la cosa suprema; oppure Abramo è perduto».
Prima che Kierkegaard la ponesse al centro della propria riflessione religiosa, la vicenda di Abramo si era già presentata al pensiero di Immanuel Kant come un caso particolare delle conseguenze cui può condurre la convinzione che nel dominio della ragion pratica sia possibile raggiungere una certezza assoluta, tale da sentirsi giustificati nel derogare a «un principio morale fondamentale che non richiede alcuna prova [come quello] che sia ingiusto togliere la vita ad un uomo per ragioni di fede» (La religione nei limiti della semplice ragione, 1793). Kant è interessato a cogliere soprattutto il risvolto politico di questa persuasione che gli appare una forma di fanatismo esaltato. Nella sua argomentazione, la figura di Abramo si presenta in compagnia di altre nelle quali questa valenza politica è più esplicita: l’«inquisitore saldamente convinto, fino al martirio, della verità unica ed esclusiva della sua fede statutaria» che commette assoluta ingiustizia verso l’eretico o il governante paternalistico che, volendo attuare nel tempo storico la perfezione incondizionata come lui la intende, realizza piuttosto «il peggior dispotismo che si possa immaginare».
Qualsiasi fede non può che rimanere problematica e custodire nel proprio cuore il dubbio e la possibilità dell’errore. La sua scaturigine è nella profondità della coscienza morale ma quest’ultima non può fare a meno del confronto incessante con la dimensione comunitaria in cui si dispiega la vita umana. Quando l’illuminismo di Kant viene esemplificato con la massima «Sapere aude!» («Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza»), si dimentica che essa non ne esaurisce la definizione completa perché il vero «principio del pensiero liberale» è quello che raccomanda di «mettersi col pensiero al posto di ogni altro (nella comunicazione con gli uomini)».
La tensione verso la totalità e l’incondizionato risponde ad un bisogno naturale ma la fame di senso che agita il cuore e la mente dell’essere umano può anche ospitare in sé un potenziale immane di distruzione. Gli assoluti devono sempre essere maneggiati con cautela, attraverso il dubbio, il dialogo critico, l’affidamento a una ragione che non può mai perdere la sua vocazione comunitaria. Nel tempo odierno in cui il tema della coesistenza tra le varie fedi religiose e tra le diverse visioni del mondo torna a essere incandescente, la filosofia può dare il suo contributo segnalando il rischio che può annidarsi in ogni tentativo umano, tanto umano, di cogliere la totalità, l’infinito, Dio. Non certo perché questa forma di esercizio spirituale, soprattutto nelle sue voci più impegnate nell’impresa di estinguere la sete dell’Assoluto, possa pretendere di dichiararsi storicamente innocente nello scatenamento dei dèmoni che portano il nome di fanatismo, intolleranza, totalitarismo. Piuttosto per la vocazione originaria a cui può sempre richiamarsi: l’ideale di una ricerca inesausta del bene e della verità, da svolgere in comune, imparando a resistere alla suggestione del possesso compiuto per mantenersi in quell’ apertura alla possibilità dell’errore che è presidio di autentica libertà per sé e per gli altri.
Del resto, è proprio la confluenza sostanziale tra la tradizione ebraico-cristiana e il pensiero liberale e democratico moderno ad aver contribuito in modo determinante nel costruire quell’ethos comune che ispira i grandi codici etici del nostro tempo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo della cui approvazione e proclamazione ricorre quest’anno il 75° anniversario. È perciò giusto e bello, nel momento in cui siamo di nuovo assordati dal rumore dei fanatismi e rischia di vincere la rassegnazione all’ineluttabilità dello scontro tra le civiltà, pensare che queste tradizioni spirituali possano mobilitare ancora insieme la loro finezza ermeneutica per rendersi accoglienti nei confronti di tutte le altre sapienze disseminate dentro e fuori l’orizzonte culturale a cui ci è capitato in sorte di appartenere, in modo che possano fecondarsi reciprocamente sostenendo lo sforzo delle donne e degli uomini nell’abitare la terra secondo princìpi comuni di pace, rispetto e condivisione.
Luciano Dottarelli