La pace “selvatica” di Yehudà Amichai
Nelle scorse settimane Papa Leone XIV ha citato le parole del poeta israeliano. Abbiamo chiesto a un’esperta di letteratura israeliana di parlarci della sua opera
25 dicembre 2025. La famiglia è riunita a tavola. I telefoni vibrano di continuo per gli auguri che arrivano da ogni parte. Tra tutti quei messaggi, c’è quello di Gianluca, un caro amico. Combiniamo di vederci nel pomeriggio. Poi una postilla inaspettata: «Forse sbaglio, ma credo che Leone XIV abbia appena citato una poesia di Yehuda Amichai». Gianluca conosce bene la mia “storia” con Yehuda Amichai. Quando lavoravo alla mia tesi di laurea sul rapporto tra l’opera del poeta israeliano e la Bibbia, fu lui a tradurmi dal tedesco — una lingua che non mi è mai riuscito di imparare — un saggio fondamentale per quella ricerca. Una citazione del Papa? Io non ne so nulla. In casa la televisione non era stata accesa se non dai miei figli, e certo non per sintonizzarsi sulla diretta da piazza San Pietro. Nonostante la festa, mi attivo. Nel giro di qualche minuto la risposta arriva. È vero. L’amica che me lo conferma è emozionata quanto me. Forse anche perché, nei mesi precedenti, abbiamo lavorato insieme, con passione e non senza difficoltà, a un evento per celebrare proprio il centenario della nascita di Amichai, tenutosi a Milano appena una settimana prima. E così, anche se il Papa non ha pronunciato esplicitamente il nome del poeta, limitandosi a citare solo un pugno di suoi versi — al resto ha pensato l’ufficio stampa della Santa Sede —, dopo due anni drammatici, un lieve ma prezioso soffio di speranza.
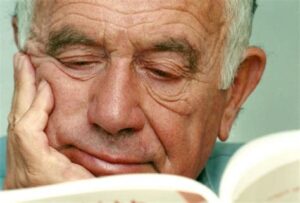
Yehuda Amichai: una delle voci poetiche più amate d’Israele, tradotto in quaranta lingue. Poeta di Gerusalemme, nato a Würzburg, in Germania, salvatosi dalla catastrofe solo per una lungimirante decisione familiare. Poeta cresciuto nell’ortodossia e divenuto laico, per tutta la vita continuò a intrattenere un dialogo intimo e fecondo con le Scritture. Ex soldato, che ha combattuto nelle guerre d’Israele fino al 1973. Poeta della pace, testimone diretto degli eventi storici, presente accanto a Peres, Rabin e Arafat alla cerimonia del Premio Nobel nel 1994.
La poesia citata da Leone XIV non è tra le più note. Si intitola Shelom bar, “Una pace selvatica”, è stata pubblicata nel 1971 ed è una sintesi esemplare del suo pensiero.
Non si tratta di un inno ottimistico o di una profezia consolatoria, ma di un’idea radicalmente alternativa, privata di ogni retorica, “selvatica” appunto, perché aspra, spontanea, delicata e profondamente terrestre.
La poesia si apre con un duplice, netto rifiuto: “Non quella di un armistizio, / né quella della visione del lupo con l’agnello”. In due versi, Amichai scarta due modelli fondamentali di convivenza pacifica nella tradizione occidentale e giudaico-cristiana. L’armistizio è la pace politica, temporanea, un mero cessate il fuoco, una pausa strategica che non risana nulla, ma semplicemente congela l’ostilità. È uno stato di mera assenza di guerra, che non implica riconciliazione o guarigione. La “visione del lupo con l’agnello”, invece, è un riferimento esplicito alla profezia escatologica di Isaia (11,6), simbolo di una pace miracolosa e assoluta, un ribaltamento soprannaturale dell’ordine biologico. È un sogno divino che cancella la natura del mondo. Amichai, figlio del Novecento, diffida di entrambi. L’una è troppo poco, l’altra troppo – e falsamente – perfetta. La pace che cerca non è una tregua né un miracolo; è qualcosa di intimo e umanissimo, paragonabile a “come nel cuore dopo l’emozione: / parlare solo di una grande stanchezza”. È uno stato di esaurimento post-traumatico, il silenzio carico che segue la tempesta dei sentimenti. Non è gioia, non è trionfo, è lo sfinimento che permette finalmente di vedere le cose con chiarezza, senza più il veleno dell’adrenalina. Questo stato di quiete è, innanzitutto, un cessare dall’emozione, dal pathos che alimenta l’odio e l’eroismo.

Al centro della poesia si staglia una dichiarazione dalla sobrietà agghiacciante: “So di saper uccidere, / perciò sono adulto”. Qui Amichai tocca il vertice della sua riflessione etica. L’adulto, nella sua accezione, non è colui che ha potere, ma colui che ha la consapevolezza tragica del proprio potenziale distruttivo. La maturità nasce da questo riconoscimento, dall’aver guardato in faccia l’ombra dentro di sé. È una condizione di colpa conoscitiva che preclude ogni facile innocenza. Alla consapevolezza adulta di saper uccidere, si accompagna l’innocenza inquietante del bambino che gioca con un fucile giocattolo capace di aprire e chiudere gli occhi e dire “Mamma”. Questo oggetto, replica grottesca della realtà, simboleggia la normalizzazione della violenza: guerra e pace, uccidere ed essere figli si mescolano fin dall’infanzia, mostrando come il conflitto venga trasmesso e interiorizzato sin dalla culla. La condizione descritta da Amichai è senza clamori, “senza il frastuono di spade ridotte a vomeri”, senza parole o trattati solenni. È leggera, breve, come una schiuma pigra, un riposo temporaneo per ferite aperte. Non un’utopia né una guarigione definitiva, ma una tregua umana fragile e precaria, una pausa necessaria nell’incertezza dei tempi. Nel cuore del testo, il grido degli orfani, che si trasmette di generazione in generazione come un testimone che non cade, ricorda il peso indelebile del passato. Infine, la pace si manifesta come fiori selvatici, che sbocciano improvvisi nell’urgenza del campo, un dono inatteso che interrompe, seppur per poco, il dolore e la fatica dell’umanità. È forse questo messaggio spoglio, antieroico, che il Pontefice ha scelto per sé. Non un inno alla vittoria, ma una preghiera laica per una tregua dell’anima e della storia. Un messaggio sobrio e umano che invita a una riconciliazione autentica, fondata sulla sincerità e la compassione.
Leggi l’intero numero di Riflessi gennaio 2026



