L’eredità fascista, oggi
Ottant’anni fa il Gran consiglio del fascismo destituiva Mussolini da capo del governo. Era la fine del regime fascista, ma non dell’eredità del fascismo, come ci spiega David Bidussa
David, il 25 luglio del 1943 il Gran consiglio del fascismo destituisce Mussolini votando l’ordine del giorno di Dino Grandi. Fu una scelta causata dall’andamento della guerra (pochi giorni prima c’era stato il bombardamento di San Lorenzo) o da un progressivo logoramento del regime?

Diciamo che sono vere tutte e due le ipotesi. La causa scatenante certamente è la guerra. Il conflitto in cui Mussolini porta l’Italia non solo porta insuccessi, ma soprattutto dura troppo. Mussolini è convinto che la questione durerà al massimo tre o quattro mesi, e che si tratti di affrettarsi a salire sul carro del vincitore. Sottovaluta però che l’Italia può sostenere il peso della guerra al massimo sette, otto mesi. Già all’inizio del 1941 il paese che non è più in grado di sopportare lo sforzo bellico, né dal punto di vista dell’opinione pubblica interna, né da quello dell’affidabilità dell’esercito, come dimostrano i rovesci in Albania, Grecia e Jugoslavia, per non parlare del disastro in Unione Sovietica. Pensa anche al Nordafrica: in Libia ed Egitto l’Italia dovrebbe contrastare l’esercito inglese, perché è lì che ci sono basi italiane e non tedesche; e invece è Rommel che prende la testa delle operazioni, la dimostrazione del fallimento militare italiano. Quindi, per rispondere alla tua domanda, direi: sicuramente la sconfitta militare accelera la fine del regime; si tratta poi di capire se un paese totalmente impreparato crolla anche per una crisi interna che la guerra di fatto accelera.
Questo comporta la necessità di capire se il fascismo, negli oltre 20 anni di guida mussoliniana, era ancora un movimento e un apparato dipendente dal duce. Il fascismo sarebbe potuto sopravvivere se la guerra fosse andata diversamente o l’Italia fosse rimasta neutrale?
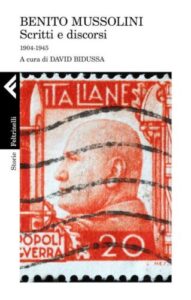
Anche se si prescinde dal condizionamento negativo che ebbe la guerra, io credo che la solidità della dittatura di fatto fosse già abbastanza in crisi. Dobbiamo infatti studiare come Mussolini agisce nella seconda metà del regime, diciamo dagli anni Trenta, rispetto al decennio precedente, quello degli inizi. A mio avviso il fallimento del regime sta nell’incapacità di creare una classe dirigente rinnovata. Direi che il legame fortissimo che unisce il regime a Mussolini ne segna anche l’intrinseca debolezza. In altre parole: il fascismo si mostra con l’andare degli anni un sistema politico incapace di rinnovare la propria classe politica. Se all’inizio Mussolini si affida ai nazionalisti per avviare le riforme e la trasformazione dello Stato, di fatto mettendo da parte chi lo aveva seguito dai tempi della marcia su Roma – pensa a chi è protagonista della riforma del sistema finanziario, della scuola, della pubblica amministrazione, della famiglia, cioè delle strutture portanti dello Stato – negli anni Trenta questo rinnovamento si arresta. Dal 1939 al 1943 ci saranno ben quattro segretari del PNF che si succedono, che diventano semplici funzionari agli ordini del Duce, di cui Starace è il simbolo. È da quel momento che il regime declina, quando Mussolini si contorna di una giovane leva, uomini attorno ai 35 anni, che finiranno per rappresentare la crisi del fascismo, e ne determineranno la fine.
Tu noti come, nelle settimane che seguono al 25 luglio, la preoccupazione dell’establishment sia ricostruire una narrazione del paese che evidenzi la continuità con il Risorgimento e l’età liberale, mentre il fascismo sarebbe una parentesi. È la lettura di Benedetto Croce, che definì appunto il fascismo come una parentesi di “barbari” nella storia italiana?

Personalmente sono rimasto di sasso a leggere le testate delle prime pagine dei giornali di lunedì 26 luglio, chiuse appena quattro ore dopo il bollettino da parte della casa regnante che informa delle dimissioni di Mussolini. Cosa succede? Be’, la verità è che non succede molto, il paese è fermo, aspetta di capire come andranno le cose. Se leggiamo “il Corriere della sera, “il Messaggero, “il Popolo” – certo giornali allineati al regime, ma che esprimevano anche i sentimenti dell’opinione pubblica – la destituzione di Benito Mussolini è percepita come un fatto che consente finalmente di riprendere un percorso interrotto vent’anni prima. Qui effettivamente si affaccia la tentazione di leggere il fascismo come una parentesi. Però credo che non dovremmo fermarci a questa prima lettura. In fondo, ogni volta che crolla un “regime” si assiste a un meccanismo simile.
Cosa intendi?

Prendi i fatti di Capitol Hill del 2021, con la fine del sistema trumpiano. Oppure la fine del regime di Saddam Hussein in Iraq, dopo circa un ventennio di dittatura. Come all’indomani del 25 luglio 1943, ogni volta si pone il problema di come interpretare quello che c’è stato prima, e scatta la necessità di prenderne le distanze, di marcare una differenza. E così, per tornare a noi, se leggiamo gli editoriali dopo il 25 luglio c’è forte questa esigenza di ricostruire un percorso nuovo, che significa sostenere la tesi che il fascismo è una parentesi; però suggerirei di metterci in una prospettiva diversa.
Quale?

È interessante esaminare quei 45 giorni che trascorrono tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943. A prima vista si ha l’impressione, leggendo i giornali, che sia stato un periodo di transizione senza storia. Leggiamo dei fascisti che vengono allontanati dal potere, del regime caduto, e infine dell’armistizio. Ma cosa succede davvero in quei 45 giorni? La mia sensazione è che oltre al tentativo di interpretare il fascismo come una parentesi ci sia dell’altro. Occorre guardare ai rapporti fra cittadino e Stato, all’approccio dell’intervento dello Stato in economia, al ruolo dei partiti politici. Insomma, credo che in quei 45 giorni ci siano già i germi dell’idea di Stato che poi si costruisce nei primi anni della Repubblica. È in quel periodo che si mette a fuoco, ad esempio, il rapporto tra governanti e governati che segnerà i primi anni della democrazia italiana. Tutto questo avviene adesso, prima ancora del 1947, quando, in vista delle elezioni del 1948, si rompe quella fragile alleanza tra i partiti del Comitato di liberazione nazionale e la DC di de Gasperi manda all’opposizione il PCI il PSI. Ebbene, se noi guardiamo a quei 45 giorni ci accorgiamo che le cose già stanno per cambiare. Diventa interessante studiare il linguaggio che si usa. Mi ha colpito ad esempio un contro editoriale di Alberto Moravia scritto su “Il popolo di Roma” il 26 agosto 1943. Il giornale era allora diretto da Corrado Alvaro, che già il 28 luglio, nel suo primo editoriale, aveva evidenziato la necessità che l’Italia ritornasse allo spirito del Risorgimento, cominciando a elaborare la formula classica del fascismo come parentesi. Bene, Moravia il 26 agosto nell’articolo di spalla scrive un pezzo che a che fare col rapporto tra il popolo e chi governa. La sua idea è che ora occorre lasciare fare agli esperti, ai tecnici, e che il popolo debba farsi da parte. È un articolo che mi ha stupito. Per questo sostengo che il linguaggio di quelle settimane successive al 25 luglio 1943 forse ci dice qualcosa di molto profondo anche dell’Italia del dopoguerra, non solo degli anni Cinquanta, ma forse anche di oggi.

È per questa idea del fascismo come corpo estraneo al Paese che non si è mai fatti i conti col passato?
Sicuramente nasce in quel periodo la percezione che manca nel nostro paese l’elaborazione del passato. La domanda che mi faccio è se l’eredità politica che ci troviamo a maneggiare oggi, fatta di molta antipolitica, demagogia, populismo, in qualche modo è anche figlia del non aver mai fatto i conti col fascismo. Dobbiamo però intenderci su questa espressione. “Aver fatto i conti col fascismo” per me non significa fare i conti con le persecuzioni razziali, o con l’uso della violenza, gli aspetti più facilmente condannabili. Al contrario, significa riflettere sul rapporto tra cittadino e istituzioni. Prendiamo l’8 settembre 1943. Nasce lì una nuova stagione politica in Italia, e mi sembra necessario studiare il ruolo dei tecnici al governo, che ritorna ciclicamente nella storia della Repubblica. C’è già allora questa idea che i cittadini siano spettatori, che debbano solo mettersi a osservare chi lavora. A me pare che se si afferma allora questa dimensione – si potrebbe dire tecnica della politica, di un mondo riservato agli esperti –, allora ecco che ci portiamo ancora oggi dietro l’eredità di un rapporto tra istituzioni e cittadinanza in cui la società civile viene esclusa. Il fascismo non può essere interpretato solo lo stato di polizia. Trovo più interessante capire qual è stato il rapporto tra cittadino e istituzioni, perché è lì la vera eredità del fascismo, con cui non abbiamo fatto i conti. Se non si realizza un’innovazione profonda del rapporto fra il cittadino e la politica poi succede appunto che lo spazio pubblico resta occupato dai professionisti, da un ceto politico che si riproduce in continuazione. Sarebbe interessante studiare l’approccio dei più giovani, diciamo i ventenni, alla fine della guerra, e poi negli anni Settanta e Novanta, per vedere come, a ogni generazione, si sia sviluppato, o non sviluppato, questo tentativo di coinvolgere le nuove leve nella politica pubblica.

Come mai non si elaborò una lettura diversa da parte dei liberali, dei democristiani e della sinistra dei socialisti e dei comunisti?
Da un lato c’è il problema del compromesso raggiunto tra forze così diverse. Pensa inoltre al quadro internazionale disegnato a Yalta, che certamente condiziona il dibattito politico. Detto questo, però va aggiunto anche altro, che ha a che fare con la cultura politica del nostro paese.
A cosa ti riferisci?
Se dovessi fare un’analisi di quel che avviene in Italia dopo il 1945 lo confronterei con la situazione degli altri paesi. Prendiamo l’Inghilterra: nelle prime elezioni dopo la guerra Churchill, l’indubbio trionfatore della guerra contro il nazismo, perde, e al potere ci vanno per cinque anni i laburisti, con un programma chiaramente di sinistra, penso ad esempio al welfare. In Italia non avviene. Da un lato c’è il fatto che siamo un paese di confine geopolitico, che per questo ne risulta condizionato. C’è però anche altro. Se vado a guardare le piattaforme politiche dei partiti tra il 1943 e il 1945 mi accorgo che per i liberali, i democristiani, i socialisti e i comunisti – forse un po’ meno per gli azionisti, che però saranno duramente sconfitti dal voto del 1948 – occorre una transizione che porti definitivamente fuori il paese dalla dittatura. Se tutti sono d’accordo sulla necessità di un referendum istituzionale, poi c’è molta prudenza su quale direzione prendere, ad esempio in economia, o in generale nel rapporto tra Stato e cittadino. È in quel momento che probabilmente si perde quello spirito profondamente rinnovatore che aveva segnato la Resistenza.
Perché la persecuzione razziale non fu percepita nella sua gravità?

Perché occorre necessariamente allargare l’orizzonte oltre il 1938. Subito dopo la fine della guerra c’è una parte del mondo politico che non considera la legislazione razziale un problema, nel senso che ritiene altre le priorità da affrontare. E poi pensa anche all’atteggiamento della Chiesa, in cui si fa resistenza ad abrogare le norme che davano “un vantaggio” sulle altre confessioni religiose. Insomma, l’Italia, per tanti motivi, affronta con molto ritardo il problema della legislazione razziale, al punto che quando mio suocero [Amos Luzzatto, n.d.r.] torna in Italia nel 1946 dalla Palestina, nel documento di ingresso si vede ancora indicare con la propria “razza”. Per avere una presa di coscienza della necessità di rimuovere tutta la legislazione razziale ci sarà bisogno di tempo. Per il reintegro nei posti di lavoro, ad esempio, bisogna aspettare la fine del 1947, l’inizio del 1948. In generale, nell’opinione pubblica il tema non fa presa, non se ne parla; comincerà a farlo la rivista “Il Ponte” all’inizio degli anni Cinquanta, ma considera che è una rivista di nicchia. Allungherei poi lo sguardo: in Italia si ragiona sul serio sulla legislazione razziale, cioè si avvia una discussione sullo statuto di cittadinanza, solo alla fine del 1978, quando per la prima volta si discute la questione del linguaggio razzista; è tra il Marzo e l’Aprile 1979, quando a Varese si sfidano il Maccabi Tel Aviv e l’Ignis di pallacanestro, che il tema dell’antisemitismo diviene oggetto di dibattito pubblico; ed è sempre nella primavera del 1979, con la messa in onda della serie americana “Olocausto” che il tema della Shoah comincia a investire l’opinione pubblica. Insomma, in Italia a lungo ci si dimentica di essere stati un paese razzista, si preferisce non parlarne. A dimostrazione, c’è un dato che occorre evidenziare.
Quale?

Il razzismo italiano non comincia nel 1938, contro gli ebrei. In realtà comincia prima, almeno dal 1936, con la proclamazione dell’Impero d’Etiopia. È allora che in Italia c’è la definizione inequivocabile di una razza inferiore. Il razzismo verso le popolazioni africane è un tema che in Italia rimane a lungo dimenticato, dovremo attendere gli anni Ottanta per le prime pubblicazioni che mettono in evidenza i comportamenti razzisti e fortemente violenti degli italiani in Africa, che mostrano la falsità del mito degli “italiani breva gente”. Questo pensiero razzista serpeggia ancora oggi, ad esempio nella paura dello straniero, nelle teorie complottiste, nel timore delle forze esterne che premono per la disintegrazione della nazione. Dunque il razzismo italiano è costituito da un lungo processo, che inizia a metà degli anni Trenta e di cui c’è ancora traccia evidente nella discussione politica odierna.
E così arriviamo appunto a oggi. L’ultima domanda riguarda il governo della destra, la cui leader si è formata in un partito, l’MSI, che si rifaceva direttamente alla repubblica sociale italiana di Mussolini. Oggi secondo te dobbiamo davvero metterci alle spalle, come ci sprona la premier, il passato e il dibattito sul fascismo e sul suo effettivo o mancato superamento?

Io penso che dietro il pensiero di Giorgia Meloni ci sia, prima ancora che una polemica su fascismo e antifascismo, una posizione antilluminista. È questo oggi il criterio per interpretare la fase politica che stiamo vivendo: da una parte chi è contrario all’idea di modernità e di progressismo (tra cui, perché no?, anche alcuni ebrei, il che spiega il feeling particolare di alcuni rappresentanti dell’ebraismo per l’attuale governo), dall’altra chi pensa che oggi si tratti innanzitutto di tornare a difendere i diritti legati alla cittadinanza. Il punto fondamentale cioè è che oggi la cultura e la lingua della destra del XXI secolo sottolinea la presenza di differenze sociali e le approfondisce, è un pensiero e una politica fondata sulle gerarchie (sociali e di censo innanzitutto). Quindi è vero che le parole di oggi non sono identiche a quelle di un secolo fa; eppure i sistemi valoriali sono confrontabili: allora, come oggi, c’è chi pensa di governare accentuando le differenze e anzi approfondendole. Basta avere la pazienza di leggersi il programma di Trieste, quello del secondo Congresso di Fratelli d’Italia del 2017: è sufficiente leggere come veniva declinata la cittadinanza, il contenuto politico o culturale di quella espressione, per comprende come per la destra di oggi, come di ieri, le libertà individuali e collettive non sono certo un valore da difendere e ampliare in vista di una maggiore uguaglianza.
Leggi anche:




Una risposta
Splendido articolo, grazie